Descrizione
In un Cilento dove “la vita è ancora scandita dai tocchi delle campane” e allietata dai profumi e dai sapori di una cucina antica, il maresciallo Pejretti ( piemontese trapiantato al Sud, dove si trova benissimo) indaga sulla scomparsa dell’anziano Aristide Alibrando, coadiuvato dai suoi uomini e, un po’ suo malgrado, da una coppia di turisti, simpatici ma incoscienti, un medico torinese e sua moglie, a volte troppo propensi a giocare ai detective e ansiosi di farsi coinvolgere in un’indagine che si sviluppa su strade forse destinate a incrociarsi: la ricerca del vecchio Aristide, i segreti della sua antica famiglia e un traffico di droga gestito dalla camorra.
Sullo sfondo il misterioso casale di Capo Vento dove tutto comincia e tutto finisce.
INCIPIT
Capitolo I – Venerdì 13 giugno, notte
“Madonna mia! Ha ancora gli occhi aperti!”
Si alzò in silenzio dalla sedia.
Gli si avvicinò lentamente, con circospezione, come se temesse di sentire improvvisamente la sua voce.
Da un po’ aveva smesso di respirare con quel rantolo che era diventato ossessionante nell’ultima ora. Poi aveva mandato un sussulto e aveva aperto gli occhi.
Quando aveva finito di mangiare e l’aveva messo in poltrona, dove se ne era stato seduto, non si era agitato. Non sembrava che provasse dolore, che sentisse qualcosa.
Non diceva niente: seguiva i suoi movimenti nella stanza con lo sguardo.
Aveva incominciato a respirare profondo, lento, poi piano piano, il respiro si era trasformato in un rantolo: come se russasse.
Aveva cercato di distrarsi, guardandosi intorno per non sentire quell’affanno.
Nelle narici l’odore di polvere antica e dell’umido del mare, che sciabordava appena sotto l’aia di mattoni, dove una volta battevano il grano.
C’era ancora un vago profumo di legna bruciata, anche se il grande camino non doveva essere stato acceso da molti anni.
Erano arrivati che il sole se ne era già andato dietro la collina.
La strada sterrata era ripida, poco più di una mulattiera: piena di buche e di sassi smossi dall’acqua delle piogge.
Aveva lasciato la macchina più in alto, sul piazzale. Con quelle buche aveva paura di non riuscire a risalire.
Non avevano incontrato nessuno.
Tutto intorno era abbandonato: olivi, campi, casale, la casina del pozzo, i viottoli tra i rovi.
Sembrava, però, che fosse successo da poco e che bastasse un’aggiustata per rimettere tutto a posto: invece erano anni.
Era davvero uno dei punti più splendidi di tutta la costa: olivi, pini, macchia, piccole baie.
Sottobraccio erano arrivati faticosamente fino al casolare, giù in fondo, proprio vicino alla riva.
Solo la tettoia esterna era crollata da una parte: forse era stato il vento oppure era marcito un sostegno di legno.
Quanti uomini e donne avevano vissuto lì: contadini, pescatori, bambini…
Adesso solo silenzio.
Non importava: ormai non importava più nulla.
Tutto sarebbe cambiato.
Aveva nello zaino pane, mozzarella, ricotta fresca, pomodori e olive, di quelle spaccate e senza nocciolo, piccanti come piacevano a lui.
Tutti lo sapevano che ne andava pazzo.
Come della ricotta di latte di bufala, dolce di suo, che non ci voleva neanche il miele, che invece lui ci metteva sempre, perché era goloso.
Glielo aveva portato, era di quello buono, adatto a dolcificare. E poi aveva il vino forte e scuro, che però sapeva del profumo dei frutti di bosco.
Lo aveva preparato il giorno prima.
“Non apriamo le ante” aveva detto “così non entra l’umido della sera.”
Dentro tutto sembrava in ordine: non avevano portato via neanche i mobili.
C’era ancora la luce allacciata: davvero strano.
Non era il momento di preoccuparsene.
Si erano seduti.
Gli aveva preparato da mangiare. Poi aveva fatto ciò che era necessario e che doveva essere fatto già da tanto tempo, mentre l’altro raccontava di quando lì era tutto coltivato bene bene e ci veniva a guardare i contadini lavorare, a bere il vino e ad ascoltare le storie dei pescatori, che avevano le barche sotto, attraccate al pontile, protetto dagli scogli… E lui raccontava le sue e si divertivano tanto.
“È morto, finalmente, ma ha gli occhi aperti e mi guarda! Chissà perché non ha chiuso gli occhi? Sembra persino che abbia capito…”
Raccolse i resti della cena, i bicchieri, dove solo l’altro aveva bevuto, che erano sul tavolino e mise tutto in un sacchetto di plastica.
Si avvicinò al viso dell’uomo. Gli passò una mano sugli occhi e glieli chiuse.
Non era pietà: voleva coprire quello sguardo che sembrava un muto, minaccioso rimprovero.
Gli sfilò, con la mano che tremava leggermente, il portafoglio dalla tasca interna della giacca.
I due uomini erano arrivati già da mezz’ora: parlottavano fuori dalla porta.
Non capiva le parole, ma stavano fumando per ammazzare l’attesa: aveva sentito lo scatto degli accendini.
Strano, tutto pareva amplificato: come quel rantolo, prima, che non finiva mai!
Un’imprecazione sommessa, ma non troppo: per farsi sentire da dentro, per dire di fare in fretta.
“Come se fosse facile morire!” pensò.
Stavano diventando nervosi. Ma non potevano entrare, finché non li avesse chiamati.
Dovevano solo occuparsi di far sparire il corpo: di nient’altro.
Aveva alterato la voce, quando si erano accordati per telefono. Sapeva con chi parlava e non li aveva voluti incontrare.
Non c’era bisogno che sapessero di più: neanche chi li aveva pagati.
“Adesso è finita!”
Lasciò la busta con i soldi sul tavolo.
Si avvicinò alla porta sul retro e agli uomini in attesa fuori gridò, mentre usciva dall’altra parte verso la notte:
“Venite! È ora!”
Quando entrarono nella stanza, c’era solo il morto, seduto sulla poltrona con il capo rovesciato all’indietro.
“Hai visto chi è?”
“No! Io non vedo, non so niente e neanche tu. Portiamolo via!”
“Dici che loro lo sanno?”
“Non è il momento di pensarci: facciamo in fretta quello che dobbiamo fare!”
“Prendiamo anche quella?”
“Ma sì! Non lasciamo niente… è meglio.”
“Levagli anche l’orologio, tanto a lui non serve più!”
Il vento rinforzava e le onde avvicinavano pericolosamente la barca agli scogli.
Ma ormai si erano staccati e in quel punto della costa la marea cresceva bene. Ora potevano mettere giù il motore. Le nuvole dell’imminente temporale si accendevano di lampi bianchi e rossi.
I due uomini si allontanarono verso il largo.
Con il vento che arrivava da terra, il mare non si sarebbe ingrossato molto ancora per un paio d’ore e loro avrebbero potuto finire il lavoro.
Quando raggiunsero Capo Vento, fermarono il motore e insieme sollevarono il grosso involucro, che stava adagiato sul fondo.
A gambe larghe per lo sforzo, lo fecero dondolare solo un poco, per non sbilanciare la barca e poi lo lasciarono cadere oltre il bordo.
Un tonfo sordo nelle acque scure e il sacco affondò rapidamente.
Se anche il suo contenuto fosse uscito, in quel punto la corrente portava fuori: il mare non l’avrebbe restituito.
Era stato un affare pulito: nessun incidente.
Capitolo II – Sabato 14 giugno
Il mattino era meraviglioso: terso e pieno di luce.
Giugno regalava splendide mattinate, che sapevano di fresco e di mare pulito dopo i temporali, che erano ancora frequenti e caricavano le montagne d’acqua preziosa per irrigare le coltivazioni, anche durante l’estate secca e torrida.
Spesso lungo la costa si incontravano ruscelli che arrivavano limpidi fin sulle spiagge.
Nell’antico palazzo della famiglia Alibrando, forse la più vecchia e influente della zona, con un cognome che risaliva ai Longobardi, la donna, magra, il viso dalla pelle ancora tesa sugli zigomi alti, le labbra carnose, che risaltavano sul pallore aristocratico cercato lontano dai raggi del sole, dentatura perfetta, capelli d’argento, raccolti in un elegante chignon, stava seduta dritta sul divano, quasi in punta.
Le mani erano abbandonate in grembo, le caviglie sottili incrociate, lo sguardo che fissava lontano.
Le vestigia di un’antica bellezza si scorgevano ancora su quel volto e soprattutto nella figura compatta del corpo modellato dagli abiti eleganti e leggeri: i seni, straordinariamente alti e sodi, tendevano il tessuto della camicetta.
Nessuno riusciva a capire l’età, che all’anagrafe risultava di settant’anni, ma sul viso quasi scolpito non si sarebbe potuto dire.
L’espressione era di chi ha l’abitudine di dare ordini e di non discuterli, mai: una matriarca.
E quello era: tutti gli interessi della famiglia passavano dalle sue mani.
La bocca quasi non si muoveva nel parlare, ma il suono della voce era fermo e profondo.
“Vi ho fatto venire, maresciallo, perché mio marito Aristide è scomparso da ieri mattina.”
“E perché, signora Alibrando, mi avvisate solo ora?”
Il voi di rispetto da quelle parti era duro a morire perché era nato molto prima delle grottesche imposizioni fasciste.
Il maresciallo Pejretti, comandante della locale stazione dei Carabinieri, aveva subito imparato a chi in paese si doveva il “voi”, a chi il “lei” e a chi il “tu” per stabilire le gerarchie.
La famiglia Alibrando era proprietaria di molta terra coltivata a vite e ulivo. Possedeva frantoi e cantine per la produzione dell’olio e del vino. Aveva interessi diffusi nelle strutture turistiche della zona e in molti altri settori di impresa.
Le origini della signora Alibrando erano poco chiare: c’era in paese chi sosteneva che arrivasse da una famiglia blasonata siciliana. Altri, più a bassa voce, confermavano che siciliana era di sicuro, ma, aggiungevano, il vecchio Aristide, già allora più che quarantenne, l’aveva trovata in una “casa chiusa” di alto bordo a Napoli.
Nonostante la legge della senatrice Merlin, ancora alla fine degli anni sessanta, un po’ dappertutto in Italia, non tutte le “case” avevano smobilitato, se non ufficialmente.
Bastava un’amicizia giusta perché si chiudesse un occhio e magari tutt’e due, specie tra le forze dell’ordine, che spesso disapprovavano il provvedimento. Salvo poi farle chiudere davvero in fretta e furia, se capitava qualche scandalo in cui fosse coinvolta persona nota e integerrima e qualora se ne fossero occupati giornali e televisione.
Si diceva in un sussurro che, da giovane, la Alibrando fosse di una bellezza mai vista e che Aristide avesse perso la testa per lei.
Infatti, dopo un lungo periodo di assenza dal paese, era tornato sposato con donna Felicita di Campo Rosso, piccolo abitato rurale nei dintorni di Trapani, dove aveva terre e villa in campagna.
Ma in realtà, sempre a bassa voce, che quella era una diceria pericolosa, si mormorava che era figlia di un cavallante in Campo Rosso, allontanata in gran fretta dalla moglie del padrone, perché oggetto delle di lui troppe e pericolose attenzioni e messa a lavorare, per spregio, dove era stata trovata.
Nessuno nel circondario aveva avuto niente da ridire sul matrimonio celebrato, si raccontava, in pompa magna a Parigi, in presenza della famiglia, ma lontano dalla casa avita, se non per il fatto che si erano persi una grande festa, degna degli Alibrando, che chissà che prelibatezze avrebbero preparato in paese per il pranzo di nozze…
Per il resto, tutti regali risparmiati!
Anche quelli per il battesimo del pupo, frutto dell’amore travolgente, ma benedetto dal santo vincolo del matrimonio, che era giunto in paese tra le orgogliose braccia dei genitori, già battezzato e presentato a tutti i maggiorenti, insieme alla bellissima neosposa.
Un anno era rimasto lontano per sbrigare gli affari che la famiglia aveva in Francia. Giusto il tempo di impalmare la giovane moglie e di benedire l’unione con un figlio maschio, per la felicità dei nonni.
Il padre Alibrando, già malato da anni, dopo pochi mesi dal ritorno di Aristide aveva chiuso gli occhi.
L’anno dopo, anche la madre era morta improvvisamente.
Le lingue più maligne dicevano di crepacuore, perché il figlio maggiore ed erede di tutte le attività degli Alibrando, ché le altre tutte femmine erano e bastava la dote, aveva sposato una puttana, di alto bordo, ma sempre una puttana.
Altri, più cattivi ancora, dicevano che della moglie di Aristide e di quanti mesi fosse durata la gravidanza, alla vecchia non importasse nulla, ma l’avesse fatta schiattare la rabbia di vedere un’altra donna spadroneggiare sui beni di famiglia e di essere messa inesorabilmente da parte.
Dalla morte di donna Alibrando, avendo assicurato la discendenza con Filippo, seguito anche lui da due bambine, donna Felicita di Campo Rosso era diventata presto la vera guida della famiglia, perché Aristide, ammaliato dalla sua bellezza e molto più anziano di lei, non discuteva mai le sue decisioni.
Era uomo gentile, minuto e gracile fin dalla nascita, un animo sensibile; gli piaceva più dipingere che occuparsi degli affari.
Negli ultimi anni se ne andava in giro per boschi, colline e costiere, spesso lungo la strada sulla collina che dominava il mare e parte delle sue terre, con la sua inseparabile valigetta di legno, che conteneva la tavolozza, le sue piccole tele e i colori, con seggiolino annesso, a dipingere alberi, case, tramonti e onde.
Qualche volta spariva per intere giornate per andare a riprodurre a modo suo le chiese rupestri che si aprivano sulle pareti del Monte Luna, sopra il paese di Corradino Castello.
Esponeva da anni regolarmente a Piani, in un atelier di sua proprietà. Molti turisti e qualche locale, forse anche per piaggeria, compravano le sue opere, trovandole originali.
Aveva organizzato a Sorrento e Napoli qualche personale e una retrospettiva a Milano da un suo amico e alcuni giornali ne avevano parlato. L’Alibrando, però, che non aveva proprio bisogno di soldi, dipingeva per sé e “per dar sfogo a quella vibrazione interna, che lo univa alla sua terra e al suo mare.”
Così aveva detto nell’unica intervista rilasciata al Regionale della Campania, che si era occupato dell’arte del Cilento e quindi anche di lui.
Da qualche anno, aveva incominciato a essere un po’ vago. Ma questo fatto non disturbava la sua pittura, che anzi acquisiva tratti più sognanti e per questo interessanti. Adesso, a ottantotto anni suonati, dimenticava le cose, i nomi e le date.
A volte era stato riaccompagnato a casa dai paesani, che lo conoscevano tutti, perché diceva:
“Ho un grande mal di testa e non mi ricordo se devo tornare a palazzo o nella villa in campagna…”
Ma non sapeva dire la strada né per l’uno, né per l’altra.
Il dottore l’aveva visitato qualche volta, ma immancabilmente aveva detto che era l’età e non ci si doveva preoccupare, che tanto in paese non gli poteva succedere nulla.
E medicine che servissero per quel problema non ce n’erano.
Quindi bisognava rassegnarsi.
Semmai si doveva badare al cuore, che faceva i capricci e batteva disordinato, facendogli mancare il fiato, quando camminava sui sentieri tra i sassi.
Capitolo III – Sabato 14 giugno, ancora mattino
“Perché, maresciallo, Aristide non ragiona bene come una volta e spesso si sperde. Ma qui da noi è sempre al sicuro. Lo abbiamo fatto cercare in giro fino adesso, anche a Castello, ma nessuno lo ha visto. È anche capitato una volta, di recente, che fosse arrivato alle chiese sul monte e si fosse fermato senza sapere più dove andare, perché era tardi e già buio, davanti alla casa di Immacolata, la vedova. Sa, quella che vive da sola fuori dall’abitato.
Lei non si è spaventata: l’ha tranquillizzato, gli ha dato cena e lo ha messo a dormire.
Me lo ha riportato la mattina con tante scuse, che lei il telefono non ce l’ha ed era tardi per uscire di casa per una donna e non aveva potuto avvisarmi. Ma, mi aveva detto, era stato bravo e le aveva raccontato qualcuna delle sue storie. A Aristide piace raccontare storie…”
“Scusate se vi interrompo, donna Felicita…”
“Era per spiegare che non mi sono allarmata subito, succede di tanto in tanto, ma è sempre restato qui, tra gente che lo conosce…”
“Certo, signora, certo, ma andiamo avanti. Quando esce che cosa va a fare?”
“Ormai fa sempre le stesse cose, cammina per un po’, chiacchiera con qualcuno in paese, si ferma al bar in piazza, magari compra ancora il giornale, ma poi lo lascia lì, perché non legge più. Molto spesso sale la collina lungo la costa, quella che scende poi a Capo Vento, si siede nei punti che lo ispirano. Si porta sovente anche la colazione e nelle belle giornate resta fuori fino al pomeriggio inoltrato. Stacca il seggiolino dalla sua valigetta di legno per sedersi dove più gli piace. Ultimamente non se ne separa mai. Lo avrà visto anche lei per le strade del paese. Quella valigetta contiene tutto il suo mondo, così dice.
Gliela aveva costruita Vincenzino Caffalà, il vecchio falegname, che era un suo compagno delle elementari, con cui ha passato la vita…”
“Va bene, signora. Dite che ha con sé la valigetta, ma come è vestito?”
“Nel solito modo. Vestiti leggeri: pantaloni marroni, giacca beige, con le toppe di pelle sui gomiti, camicia azzurra, con il foulard marrone, borsalino bianco in testa per il sole e scarpe con la suola spessa, per camminare sui sentieri, testa di moro.
“Come dice?”
“Testa di moro: il colore delle scarpe.”
“Certo, appunto.”
“È perché, maresciallo, ultimamente fa un po’ di fatica a muoversi e qualche volta gli manca proprio il fiato, ma è impossibile tenerlo fermo in casa: lui è fatto così. Le medicine le prende e non le prende e allora almeno le scarpe devono essere solide e sicure.”
“Avrà il cellulare con sé… Avete provato a chiamarlo?”
“No, maresciallo, il cellulare non lo ha mai voluto. Nostra figlia Anna gliene ha regalato uno: semplicissimo con numeri e lettere grandi. Non l’ha mai neanche provato! È fatto così: all’antica…”
“Ha denaro con sé, preziosi? Che so, un orologio importante o altro?”
“No. Il portafoglio con i documenti, un biglietto con l’indirizzo, anche se tutti sanno dove stiamo, i numeri di telefono di casa e i cellulari mio e di Filippo, mio figlio, e anche le mail. Assolutamente null’altro, oltre due pezzi da cinque euro, che questa nuova moneta non ha mai voluto imparare a usarla bene. Intanto, di qualunque cosa abbia bisogno, la può prendere a credito, che tutti ci conoscono. I soldi per il caffè o per offrire qualche cosa a un amico, eventualmente… Ha anche l’orologio, anche se l’ora per lui non ha più importanza. Uno Swatch da pochi soldi con il quadrante e i numeri talmente grandi che fanno ridere. Gliel’ho regalato io e quello l’ha tenuto, perché, mi ha detto una volta, gli fa allegria.”
“Ho capito. È successo qualche cosa di particolare ieri o l’altro ieri? Qualche cosa che lo abbia turbato?”
“È un po’ che cerco di non affaticarlo e di ridurre al minimo i suoi interventi sulle cose di casa e di famiglia. Comunque gli racconto sempre tutto… Non è successo niente di particolare. Certo…”
“Continuate, signora” la incoraggiò il maresciallo.
“Si infastidiva tanto, quando gli riferivo delle insistenze dell’avvocato Mastretta per acquistare una sua proprietà proprio sulla collina che va a Capo Vento. Pezzi di terra di scarso valore, ma in una posizione magnifica, che lui ha anche dipinto in tanti modi. Guardi, maresciallo, uno è appeso anche là su quella parete…”
Il militare si alzò e si avvicinò al dipinto che ritraeva un bel pezzo di campagna coltivata a ulivi e orti, le linee morbide della collina e su un pianoro, vicino al mare, un casolare di pietra dalle pareti di tutte le sfumature di grigio, fino all’azzurro, i coppi vecchi coprivano il tetto.
La tecnica era quella dei macchiaioli:
“Che posto fantastico!” pensò Pejretti. “Mi piacerebbe starci una volta in pensione.”
“Bello, signora, complimenti, è molto… coinvolgente!” continuò a voce alta.
“Comunque” proseguì donna Felicita “non credo che ci sia stato qualche cosa di particolare ieri o l’altro ieri, che possa averlo preoccupato o irritato… Non c’è altro. Fatelo cercare, maresciallo, chissà dove si è perduto. È anziano, deve prendere le medicine, è svanito, ma io gli devo tutto: riportatemelo a casa!”
“Sì, maresciallo, aiutateci!” disse una voce dietro le spalle del militare.
L’ingegner Filippo Alibrando, sui cinquant’anni, aspetto curato ed elegante.
Si occupava di antiquariato e aveva un negozio molto rinomato in via Vannella Gaetani a Napoli, a due passi dalla riviera di Chiaia e un punto di vendita anche a Piani, nella zona del passeggio che veniva aperto solo durante la stagione turistica, proprio vicino all’atelier del padre.
Donna Felicita l’aveva aiutato a avviare l’attività per permettergli di coltivare la sua passione per l’antico e in parte perché con le imprese della famiglia non se la cavava altrettanto bene.
Bell’uomo: alto, asciutto e muscoloso, brizzolato, occhi chiari; era amante dell’equitazione, della vela e delle belle donne.
Sposato e, per l’appunto, separato.
La moglie era ritornata tre anni prima a Roma dai genitori, con i due pargoletti, che lui vedeva sì e no una volta al mese. Massimo disappunto di donna Felicita, che doveva contribuire con le rendite di famiglia agli alimenti della Romana, come la chiamava lei, che non l’aveva mai vista di buon occhio.
Per il figlio, che le somigliava molto, stravedeva e lo aveva sempre un po’ viziato.
Il padre, invece, pur orgoglioso del suo unico figlio maschio, prima di perdere memoria e preoccupazioni, lo avrebbe voluto più presente negli affari di famiglia.
“Per stimolarlo ad assumersi le sue responsabilità, cara. Non devi tenerlo fuori da tutto, prima o poi noi non ci saremo più e sarà lui a doversi occupare delle attività…” diceva spesso alla moglie, che decideva, come sempre, da sola.
“Stamattina presto, appena sono rientrato, la mamma mi ha detto che papà non è di nuovo tornato per la notte. Ho mandato in giro subito alcuni nostri dipendenti a cercarlo, ma non abbiamo trovato ancora niente, nessun segno. Sono ore che lo cercano: adesso sono molto preoccupato. Papà potrebbe essere ruzzolato giù da qualche parte, potrebbe essersi fatto male e più passa il tempo…”
“State tranquillo, ingegnere, metto subito i miei uomini in allerta e faremo tutto il possibile! Ma, mi dica ancora una cosa… Il papà ha nemici in paese? Magari vecchie ruggini…”
“No, nessuno che io sappia… Forse… ma non voglio parlare male di nessuno: giusto per dire tutto.”
“Dite, dite: anche le cose insignificanti possono essere utili.”
“Vincenzo Munafò, il vecchio pescatore, quello che ha una casupola sul mare vicino a Capo Vento, ha sempre questionato con il babbo per una faccenda di confini. Le nostre proprietà sono vicine al suo pezzo di terra e alla rimessa, dove tiene la barca. Ha sempre sostenuto che mio padre avesse preso un pezzo con il ruscello che noi adoperavamo per irrigare e che, lui dice, stava sulla terra che apparteneva ai suoi nonni. Vecchie beghe di paese, signor maresciallo, ma il Munafò è venuto qualche volta a male parole con papà. Una volta anche in piazza, qui davanti… ho dovuto intervenire un po’ duramente per calmarlo ed evitare il peggio.”
“Il peggio in che senso?”
“Sì, era proprio furente e forse… ma no, niente: impressioni. Comunque non credo che… ormai è vecchio anche lui.”
“Ma lo ha aggredito, picchiato?”
“No, ma no, maresciallo, parole e gesti, si sa i paesani come sono…”
“Grazie per l’informazione, farò controllare. Avete una fotografia del papà?”
Capitolo IV – Sabato 14 giugno, primo pomeriggio
Il maresciallo Pejretti, torinese di sette generazioni, era un bell’uomo di quarantotto anni, sul metro e settantacinque, baffi piccoli e curati, capigliatura folta e ondulata, ancora pressoché corvina, tenuta un po’ troppo lunga, in barba al regolamento. Gli piaceva mantenersi in forma, ma era in eterna lotta con la sua passione per la buona tavola, che sua moglie, esperta di cucina, alimentava senza esagerazioni.
Era risultato il primo del suo corso di arti marziali e di tiro con la pistola e anche se negli anni aveva perso un po’ del suo smalto, restava forte e scattante, quando era necessario.
Era stato mandato otto anni prima a comandare la caserma di Corradino Castello, che faceva Comune insieme alle frazioni di Marina e di Piani.
Poteva contare sulla collaborazione del brigadiere Murru, degli appuntati Solimano e Volterra e di tre giovani carabinieri: Bertoli, Salimbeni e Sammartino: tutti si sarebbero buttati nel fuoco per lui.
Lo avevano trasferito da Pancalieri, poco fuori Torino, in quella stazione, perché il precedente maresciallo era diventato troppo accomodante, tirandosi dietro tutta la sua squadra, tranne il brigadiere Murru, che non ne voleva sapere di certe vicinanze e di certi favori.
Alla fine, non potendone più, in borghese e mentre era in licenza per non dare nell’occhio, Murru era andato a parlare in maniera riservata con i suoi superiori a Salerno.
Vista la delicatezza della situazione, che non dava ancora ragione di credere che ci fossero reati, ma faceva nascere il timore che si stesse costruendo una rete, che fatalmente avrebbe portato i militi dell’Arma a chiudere troppi occhi con chi li favoriva in tutti i modi, si decise, dopo alcune settimane di verifiche e riscontri, per il trasferimento del maresciallo in un paese in provincia di Trento, in una stazione comandata da un tenente, che aveva fama di uomo di ferro:
“Che lo raddrizzasse lui!” aveva detto il colonnello, firmando l’ordine di trasferimento.
Avevano affidato nel frattempo il comando pro tempore al brigadiere Murru, che per sei mesi aveva sopportato le occhiate di sospetto e risentimento dei suoi commilitoni, puntualmente trasferiti e sostituiti uno dopo l’altro con forze, per così dire, fresche.
In capo a sei mesi, appunto, venne comandato per quella destinazione il Pejretti, uomo integerrimo e fedelissimo all’Arma, informato di tutto e pronto a sacrificarsi per una destinazione tanto lontana dal suo ambiente.
Subito, però, non l’aveva presa bene:
“E vada l’Obbedir tacendo! Ma da Pancalieri a Corradino Castello!”
Aveva capito che laggiù la situazione era delicata.
Ma lui aveva due buoni motivi per non essere entusiasta.
Il primo era sua moglie: non sapeva come dirglielo e soprattutto non sapeva che cosa avrebbe detto lei.
Il secondo era l’indagine che stava portando avanti.
Aveva scoperto in collaborazione con la Guardia di Finanza un grosso giro di sofisticazioni alimentari. Il traffico permetteva a una catena di aziende di mettere sul mercato molti prodotti simili, di marca diversa, con additivi e sostanze che da un lato abbattevano i costi di produzione per la scarsa qualità e dall’altro permettevano di evadere l’IVA per svariati milioni ogni anno.
C’erano corruzioni e collusioni e qualche pezzo da novanta era coinvolto.
“… E adesso mi tolgono tutto di mano? E no, per Dio!” E andò a fare le sue rimostranze ai superiori.
Si dimostrarono tutti molto comprensivi, ma fermi.
Primo: “Nessuno è indispensabile, ma tutti siamo utili!”
Secondo: “Lei è proprio l’uomo giusto per la situazione che si è creata a Corradino Castello!
Non possiamo cambiare scelta.”
Non gli restò che dire al signor colonnello, come Garibaldi alle porte di Trento:
”Obbedisco!”
Ma aggiunse di suo:
“Comandi!”
Era un carabiniere: non poteva fare diverso.
Gli rimase a lungo, però, il sospetto che gli avessero raccontato solo mezza verità: quella che si poteva.
Gli avevano detto di appoggiarsi al Murru, che tanto attaccamento al dovere aveva dimostrato.
Così aveva fatto appena giunto alla nuova sede.
Il maresciallo, consigliato dal brigadiere, che era la memoria di almeno quindici anni di vita di paese e paesani, assunse un atteggiamento collaborativo con tutte le autorità locali, maggiorenti e popolani. In più Pejretti aveva un’arma importante che lo rendeva simpatico: un sorriso ironico e rassicurante nello stesso tempo, che si apriva su un viso dove gli occhi azzurri catturavano gli sguardi delle donne del paese e mantenevano viva l’attenzione di sua moglie, bella donna, ma attenta a marcare il suo territorio.
Era giusto nelle questioni, ma distaccato e irreprensibile, anche se istintivamente molto umano, quando riteneva necessario comprendere situazioni particolari.
Come quella volta in cui il giovane Mario, il più grande dei cinque figli di Salvatore Prenestina, operaio edile, morto precipitando da una impalcatura in un incidente dai contorni oscuri, si era rubato un motorino e l’aveva rivenduto per procurare soldi alla mamma, che non ce la faceva a sfamare i quattro più piccoli.
Lo avevano preso subito e portato in caserma.
La mattina dopo, però, il ricettatore che aveva comprato la refurtiva non solo non si accorse che il motorino era di nuovo sparito, ma non si ricordò più di avere visto né conosciuto Mario. Forse per le lievi contusioni che si era procurato scivolando durante la notte per le scale.
Il motorino era sotto casa del padrone al suo posto consueto, con tanto di catena legata al palo.
E quindi nessuna denuncia di furto.
La mamma la settimana dopo aveva un posto da governante presso una facoltosa famiglia di un paese vicino, grazie ai buoni uffici del locale maresciallo.
E Mario era tornato a scuola con la minaccia che, se fosse mancato un giorno solo, Pejretti in persona e il carabiniere Salimbeni, che era particolarmente grosso, sarebbero andati a prelevarlo per portarlo al gabbio.
Il maresciallo conosceva bene la famiglia Alibrando e aveva sentito tutte le voci che correvano su donna Felicita e anche qualche pettegolezzo sulla vita sentimentale un po’ burrascosa del rampollo di famiglia. Ma, lo sapeva, in paese parlare di corna era uno dei passatempi preferiti.
Nulla su di loro si poteva dire di vicinanze o collusioni pericolose: al momento almeno. E il primogenito risultava comunque in regola con la legge.
Il vecchio Aristide poi lo conosceva bene, qualche volta gli aveva anche parlato di colori, tempere e acquerelli, resa di luce e prospettive. Anche lui, quando non era di turno, si dilettava di pittura e perfino a copiare i classici e sua moglie, che gli voleva un mucchio di bene, gli diceva che sembravano veri.
Ultimamente lo aveva incontrato sulla passeggiata a mare con la sua valigetta di legno con il seggiolino attaccato e si era molto stupito perché non lo aveva salutato come al solito e in più aveva notato che aveva tutte e due le scarpe slacciate, mentre l’uomo era sempre molto proprio e vestito con cura.
Ma la cosa che più lo aveva colpito era lo sguardo perso, gli occhi acquosi e privi di luce.
Aveva pensato che fosse preoccupato per qualcosa, e dopo averlo salutato frettolosamente, aveva tirato dritto, anche perché aveva un appuntamento in Comune, ma ora era tutto più chiaro.
Chissà dove vagava adesso o in quale anfratto poteva essere caduto quel pover’uomo?
Non sembrava possibile che lo avessero aggredito per derubarlo: soldi addosso niente. Nessuno rapina per dieci euro, per di più conoscendo il signor Aristide e in paese nessuno gli avrebbe torto un capello: neanche quelle due o tre teste calde che c’erano. Neanche gli scagnozzi della camorra potevano avere interesse a far del male a una persona così in vista e rispettata.
Magari un balordo da fuori… tutto era possibile.
Il Munafò era un anarchico, in caserma lo conoscevano bene.
Un po’ violento, qualche pugno per motivi politici con gli ultimi fascisti, che anche lì in paese stavano scomparendo, insieme ad anarchici e comunisti: razze in estinzione.
Comunque un lavoratore e tutto sommato una brava persona.
Non ce lo vedeva nei panni dell’aggressore per un confine, fino a far scomparire l’Alibrando.
La demenza era una brutta bestia e non guardava in faccia a nessuno: ricchi e poveri.
Riflettendo sulle tragedie della vita, il maresciallo si ritrovò in caserma.
Guidava sempre un po’ in trance, quando rimuginava tra sé e sé e ormai le curve da Marina a Castello le conosceva a memoria, tornanti compresi.
Era una casa di due piani: inferriate alle finestre, un giardinetto intorno e l’entrata guardata dalle telecamere. Le macchine entravano da dietro, dove c’era uno spiazzo, chiuso da un pesante cancello di ferro e cintato di rete e filo spinato, che sarebbe entrato chiunque.
Sul cancelletto di ingresso di metallo campeggiava un cartello giallo con la scritta nera:
“Zona Militare. Limite invalicabile”.
Chissà perché tutte le volte che lo leggeva gli scappava da ridere.
“Murru” disse, incontrando il brigadiere in corridoio “venga nel mio ufficio. È scomparso Aristide Alibrando, questa è la fotografia, dirami un’informativa ai paesi vicini, alle stazioni ferroviarie e a quelle dei pullman…”
“Il vecchio pittore è scomparso?”
“Sì, Murru, da ieri mattina, quando è uscito di casa. Prenda qui: le ho scritto come era vestito. Aveva con sé una valigetta di legno da pittore.”
“Ma lo lasciano ancora uscire da solo?” disse stupito il brigadiere.
“Si fidano! Qui li conoscono tutti.”
“Ma si sapeva che non ci stava più tanto con la testa…” insistette Murru.
“E cosa vuole che le dica…” tagliò corto Pejretti.
“Telefoni a tutti gli ospedali e pronto soccorso della zona e dia la descrizione dello scomparso, caso mai si presentasse successivamente. Dica ai colleghi della Polizia di fermare chi eventualmente lo accompagna, finché non arriviamo noi.”
Murru prendeva nota su un taccuino delle cose da fare, ma sapeva che non era finita. E infatti il brigadiere continuava.
“Ci sono due persone da sentire. Mandi qualcuno a cercare Munafò Vincenzo e mi convochi qui in caserma l’avvocato Mastretta. Anche se probabilmente faremo un buco nell’acqua, ché di vecchi ne scompare uno al giorno. Però proviamoci lo stesso, almeno per donna Felicita. Mi sembrava sinceramente addolorata.”
Si agitò sulla sedia e riprese dopo un piccolo colpo di tosse:
“Una donna particolare, mi ha fatto proprio una bella impressione e… molta pena.”
Poi concluse, come se gli fosse venuto in mente un’idea nuova:
“Incominci con discrezione a prendere informazioni sulla famiglia. Così… per routine. Non si sa mai. Si faccia aiutare dall’appuntato Volterra. Mandi in giro anche Bertoli, Salimbeni e Sammartino: due in macchina e uno a piedi.”
“Comandi!” rispose Murru allontanandosi.
“Ancora una cosa, telefoni in Comune e alla Protezione Civile, dica di organizzare volontari per la ricerca del vecchio. Trovino più gente che possono. Distribuisca le fotografie e la descrizione.”
“Comandi!” ripeté il brigadiere, fischiando sommessamente tra i denti e scarabocchiando con scrittura piccola e nervosa gli ultimi ordini.

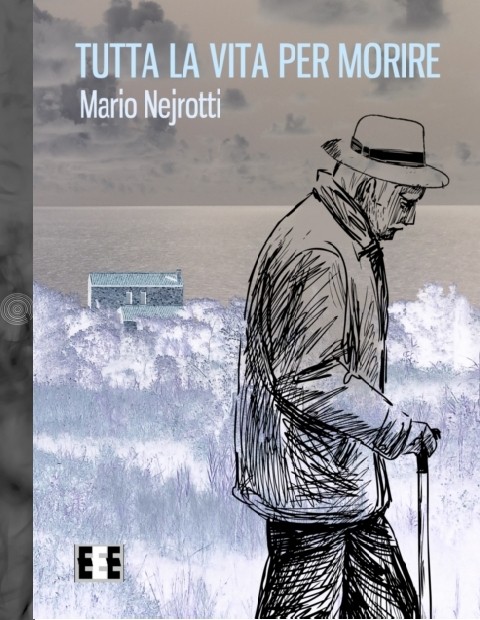



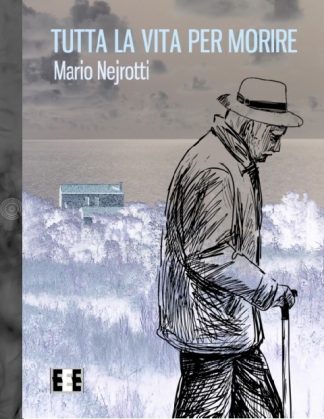
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.