Descrizione
Gennaio 1860, Torino brulica di patrioti e spie. I caffè accolgono le discussioni di chi vuole cacciare dall’Italia lo straniero, buttare a mare i Borboni e liberarsi del Papato.
Atmosfera affascinante per un giovanotto ardente, cacciato dal seminario in cui lo obbligava lo stato di cadetto della nobile famiglia dei Malafonte.
Francesco Maria fa il giornalista alla Gazzetta del Popolo. Ma si prepara per lui un futuro più emozionante.
Garibaldi organizza la spedizione in Sicilia; a Corte si tessono intrighi internazionali; i progetti di Cavour non si accordano con le ambizioni del Re.
Malafonte si trova proiettato in un mondo ambiguo e violento tra personaggi decisi e spietati: donne e uomini dei neonati servizi segreti del Regno Sabaudo.
Qual è il segreto di Garibaldi che permetterà ai Mille di sconfiggere i potenti eserciti dei Borboni e del Papa?
Malafonte e i suoi dovranno scoprirlo. Seguiranno la spedizione a Genova e poi in Toscana per riuscire a concludere la missione, in un’Italia che non c’è ancora e dove tutti sono contro tutti.
INCIPIT
Prologo
Un lampo, uno squarcio di luce e il profilo tetro dei ruderi della Chiesaccia. Due torri mozze e le rovine del castello: lassù, sulla collina.
Non era facile raggiungerla.
La strada non correva diritta.
In quelle contrade succedeva di vedere la meta vicina, ma poi ci si addentrava all’improvviso in selve oscure e si scendeva a precipizio in orridi antichi. La via sprofondava tra alte pareti di tufo, tagliate a picco, dove si aprivano orbite vuote, senza tempo.
Dovevamo fare in fretta, arrivare prima dell’alba: impedire la consegna, impadronirci delle casse e liberarci degli altri, se fosse stato necessario.
Verso sera aveva incominciato a tirare un forte vento freddo da est. Le nuvole si erano presto addensate sulle montagne, scendendo verso le colline e il mare: la pioggia era arrivata in fretta.
Non avevo mai visto un diluvio come quello.
Era primavera: ma nulla di dolce aleggiava intorno.
La notte era scura, nessuna luce rischiarava il cielo nero. Solo fulmini bianchi e rossi fendevano il buio, correndo sull’orizzonte. Tuoni violenti frustavano l’aria.
I cavalli, come indemoniati, volavano sul terreno che non avrebbe retto un carro neppure per un momento.
O era già a destinazione o sarebbe rimasto impantanato da qualche parte alla mercé di chiunque, pensavo, piegato sul collo dell’animale.
Ora si saliva e dovevamo rallentare, non scorgevo alcun lume, anche se la Chiesaccia avrebbe dovuto essere in vista.
Se erano là non avevano acceso lampade o fuochi.
La pioggia continuava.
Le pareti di tufo si erano abbassate e si intravedeva il bosco ai lati.
Al chiarore dei lampi sei cavalieri correvano paralleli a noi su un’altra strada tra gli alberi.
Non ci avevano visti. Arrestammo i cavalli. Non dovevamo rischiare di farci scoprire.
Cavalieri al galoppo nella foresta a quell’ora, non potevano essere che loro: i francesi, diretti alla chiesa sconsacrata.
Dopotutto il messaggio era arrivato: non eravamo riusciti a impedirlo.
L’acqua e il buio ci avevano protetti.
«Lasciamoli andare» sentii sussurrare al mio fianco.
«Potremmo attaccarli subito e sorprenderli. Siamo alla pari» propose Sattanino.
«Forse potrebbe essere il momento…» azzardai.
«Buono, Malafonte. State tutti fermi: non si fa nulla. Lasciamoli passare – impose Vittorio. – Gli ordini sono di evitare scontri inutili con i francesi. Che combattano tra loro, poi noi ci occuperemo di chi è rimasto in piedi. Fate come il maestro Ling: restate impassibili.»
Il cinese lo guardò sollevando il sopracciglio destro.
Controvoglia tacqui, mentre rimuginavo. E se si fossero accordati tra loro per spartirsi il contenuto delle casse? Si trattava di una somma enorme. Avrebbe fatto gola a chiunque. Tutti insieme avrebbero potuto essere davvero troppi per noi.
Pensavo all’azione imminente, alla lotta che mi aspettava e alla morte, che poteva arrivare in ogni momento con una pallottola, un colpo di baionetta o di pugnale.
Eppure non era passato tanto tempo da quando ero un giovane seminarista mancato, arrivato a Torino pieno di sogni e di ardore per fare il giornalista: allora la morte mi sembrava un affare che riguardava solo gli altri.
Capitolo I
La mattina di mercoledì 4 gennaio 1860 Torino si era svegliata sotto un cielo nuvoloso.
Per tutta la notte la città era stata immersa in una fitta nebbia, che persisteva in pesanti volute, anche se si era levato il vento.
Verso le nove in via di Po circolava poca gente al riparo dei portici.
Ero in ritardo: mi succedeva troppo spesso quando al mattino dovevo andare al lavoro alla Gazzetta del Popolo, come amichevolmente veniva chiamata in città. Il suo vero nome, L’Italiano-Gazzetta del Popolo, non piaceva a nessuno.
Oggi doveva uscire sul giornale la lettera vergata di pugno da Garibaldi e poi corretta da Govean, il gerente della testata e mio datore di lavoro, così almeno si spettegolava in redazione.
L’aveva dovuta scrivere per mitigare le frasi pronunciate dal balcone del suo albergo, durante la manifestazione degli studenti, che incitavano la nazione ad armarsi per essere libera e unita.
«Un milione di fucili, per un milione di soldati!»
Quell’uomo sapeva usare le parole e infiammare il cuore di tutti, ma soprattutto dei giovani che, se avessero potuto, si sarebbero arruolati subito tra i suoi volontari.
Proprio quella frase aveva creato un vero putiferio al Governo, facendo traballare il povero La Marmora, che era dovuto correre ai ripari, e non senza un forte imbarazzo, con gli ambasciatori di tutti i maggiori Stati d’Europa e d’Italia.
Che uomo il Generale!
Questi ultimi fatti, confusi e appassionati, mi suggerivano di fare ancora più attenzione a quello che scrivevo: la situazione politica del Regno si complicava sempre di più e il giornale non poteva correre rischi, assumendo posizioni troppo decise. Certo io facevo fatica a star buono, ma c’era chi mi teneva d’occhio: e meno male.
Oggi non potevo proprio arrivare tardi.
Il gerente avrebbe notato subito la mia assenza, aggirandosi più nervoso del solito tra scrittoi e macchine, e non me l’avrebbe perdonata.
Abitavo in piazza Vittorio Emanuele, affittavo una camera, dalla cui alta finestra potevo vedere il fiume, in un grande alloggio, molto pulito, con l’acqua corrente interna.
C’erano altri cinque pensionanti: tutti uomini, di diversa provenienza. Ci vedevamo qualche volta per colazione o per cena nella sala da pranzo, serviti al tavolo da Liberta. Veniva dall’Abruzzo e si mormorava fosse la figlia di carbonari fuoriusciti del Regno delle Due Sicilie. La ragazza lavorava per aiutare la famiglia.
Si diceva, ad ancor più bassa voce, che concedesse i suoi favori a Gabriel, non ne conoscevo il cognome, arrivato qualche mese prima. Un bel giovane bruno con gli occhi scuri, non troppo alto, come è frequente tra i sardi, ma molto muscoloso e sempre profumato. Era riservato e stava spesso fuori la notte: una sera, che si rivelò poi per me molto importante, ci eravamo incontrati da Stratta in Piazza San Carlo.
Frequentavo spesso quel posto e non solo perché la caffetteria dei Fratelli Stratta produceva una fine pasticceria e perché era un fornitore della Real Casa.
Quel locale mi piaceva per due motivi: il primo era che i borghesi della città lo frequentavano volentieri e spesso si sentivano sussurrare discorsi repubblicani, che facevano infuriare e inorridire ai tavoli vicini gli avventori dell’aristocrazia più conservatrice.
«Uguaglianza!»
«Più potere al popolo!»
Frasi che infiammavano la mia giovane età, anche se per prudenza non lo davo a vedere e mi calavo nei miei fogli fingendo di scrivere.
Mi divertiva assistere a quelle baruffe: il più delle volte finivano prima di degenerare, ma talvolta qualche spintone ci era scappato, sedato dai camerieri, soprattutto da uno, di statura imponente che univa un procedere dondolante, sui piedi piatti, a una agilità formidabile. Antenore si chiamava e pareva che fosse stato con gli Stratta fin dall’inizio, da quando c’era ancora il Cavalier Reina. Tutti lo conoscevano e nessuno lo provocava.
Lì la luce di sera era sufficiente per leggere e scrivere anche davanti al locale. Questo era il secondo motivo per cui quella caffetteria mi attirava tanto: aveva l’illuminazione a gas, sia fuori che dentro, molto più brillante e rara delle lampade a olio.
Era passata da un po’ l’ora di cena, me ne stavo seduto a scribacchiare, leggere, ma soprattutto ad ascoltare, come al solito, quando incrociai gli occhi del mio coinquilino Gabriel, che mi osservava. Accennai un saluto e lui, cordiale, mi rispose con un sorriso, ma non si alzò per venire da me. Era in compagnia di un uomo dalla schiena possente, che mi voltava le spalle. Continuarono a parlare tra loro.
Decisi che era più discreto non insistere.
Seduto al tavolo di fronte a me c’era un giovane magro e biondo, dall’aspetto gracile.
Si portava spesso un fazzoletto alla bocca per coprire la tosse. Ascoltava, con insofferenza crescente e sempre più evidente, una discussione tra gli avventori di due tavoli vicini: repubblicani e monarchici.
Gli animi si accesero al punto che, per una parola di troppo contro i repubblicani, il giovanotto si intromise e rimbeccò vivacemente i tre aristocratici, che si alzarono in piedi e l’apostrofarono con violenza.
Il biondino, vistosi osservato da tutti, raccolto il pastrano, si allontanò dalla sala.
Poteva avere qualche anno meno di me.
Mi accorsi che i monarchici confabulavano tra loro e lo guardavano mentre usciva.
Intuii le loro intenzioni e li precedetti fuori dal locale, mentre Antenore si avvicinava rapido al loro tavolo.
Ero confuso, non sapevo che cosa avrei fatto per difendere quel ragazzo, se fosse stato necessario.
Ero disarmato, ma volevo proteggerlo.
Dopo pochi passi, più che vederlo nel buio della via, ne sentii la tosse.
Era piegato in due, squassato da un accesso terribile.
Lo vidi arrivare di corsa, era solo, gli altri due doveva averli calmati Antenore. Scorsi il luccichio di una lama: quell’uomo voleva lavare l’onta con il sangue. Mi era stato insegnato tante volte a casa mia: un gentiluomo deve reagire all’offesa per non perdere l’onore.
Ma io non ho mai apprezzato l’educazione di mio padre.
Appoggiata al muro scorsi una pala e l’afferrai.
L’aristocratico correva con l’arma in pugno.
Nell’altra mano stringeva il manico del bastone animato, che molti in quell’epoca pericolosa portavano con sé per difesa.
Nell’ombra non mi vide.
Una veloce rotazione della pala e il colpo arrivò violento con un rumore metallico sul polso teso nell’ansia di colpire.
Un urlo.
Si voltò nella direzione del colpo ricevuto con occhi più spaventati che furenti.
Un’altra rotazione e la seconda botta lo mandò a terra sconcertato a strisciare all’indietro per sottrarsi all’attacco.
La lama e il bastone, abbandonati per la sorpresa, erano rimasti a terra, vicino ai miei piedi.
Mi chinai e li raccolsi entrambi.
Il biondino era addossato a un portone e mi guardava. Pareva sbalordito, ma non molto spaventato. L’uomo si lamentava per il colpo ricevuto, tenendosi il polso. Non sembrava intenzionato a rialzarsi subito.
Afferrai il ragazzo per un braccio.
«Venga via, signore, presto!»
Ci mettemmo a correre per la strada deserta e mal illuminata da pochi lampioni a olio.
Giunti al fiume, il mingherlino era senza fiato, ma non tossiva.
«Grazie signore, le sono debitore. Non so perché ho agito così, ma quegli aristocratici…»
«Ora basta, se ne vada a casa, signore. E cerchi di evitare quell’uomo.»
Si allontanò coprendosi la bocca con il fazzoletto sporco di sangue.
Cambiai idea e lo raggiunsi. Decisi di accompagnarlo, perché non si reggeva in piedi. Avevo rinfoderato la lama nel bastone e passato il braccio destro sotto il sinistro del giovanotto per sorreggerlo.
Facemmo un largo giro per raggiungere via Dora Grossa, dove lo accompagnai su dalle scale di un palazzo.
Il ragazzo abitava in una stanza piccola, ricavata in una soffitta: un’angusta finestra ad abbaino dava un poco d’aria all’ambiente basso e polveroso.
Un letto, coperto da un pagliericcio, un lenzuolo sporco e una coperta. Un tavolino: sopra una lampada a olio; una sedia, un canterano, una brocca in un bacile e molti libri accumulati ovunque.
«Sono uno studente – spiegò, rispondendo alla mia silenziosa curiosità – ma non so per quanto…»
Lo interpretai come un triste presagio, ma non so perché il tono della voce mi sembrò un po’ teatrale. Pensai che volesse esagerare per impressionarmi.
«Mi chiamo Luigi Sattanino e vengo da Alba. Mio padre fa il macellaio e mi ha mandato a Torino per studiare.»
Gli dissi il mio nome.
«Quando mi agito, mi viene la tosse e qualche volta esce un po’ di sangue, ma, se riesco a dormire, poi va tutto bene. Non so proprio come ringraziarla, signore. Se non fosse stato per lei…»
Si voltò verso il muro e si addormentò quasi subito. Doveva essere sfinito.
Rimasi con lui, finché non fui certo che riposava profondamente, poi scivolai fuori da quella stanza.
Mi ero domandato tante volte, leggendo di eroi e cavalieri, che cosa avrei fatto in situazioni pericolose e se sarei stato capace di lottare per aiutare qualcuno, rischiando la mia vita, come avevo già fatto una volta, quando ero poco più di un ragazzo.
Ora ne avevo avuto la conferma: ero un incosciente.




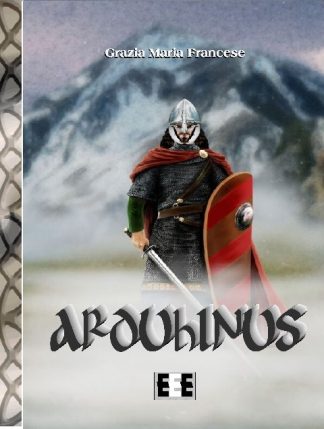

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.