Descrizione
Giacomo Savelli, quarantenne autore di musical, eredita, oltre a una cospicua somma in denaro, un’antica casa in un piccolo centro dell’Umbria, e vi si trasferisce, immaginando di condurre una vita tranquilla. Una sera, rientrando, trova il portone socchiuso e, nell’androne, una bimba di circa dieci anni che sta ammirando la sua collezione di automodelli. La bimba non fornisce a Giacomo nessuna spiegazione circa la sua presenza, anzi, assume un atteggiamento ostile e l’uomo, spazientito, la spinge in strada. Poco dopo, però, si accorge che la bimba ha dimenticato il suo diario scolastico, sul quale è scritto il suo nome, Adelaide Assensi, la classe e l’istituto che frequenta. Giacomo, l’indomani, riporta il diario alla scuola, e qui apprende che la piccola risulta scomparsa, volatilizzata, da circa due anni. Giacomo ha visto un fantasma o ha avuto una visione? Oppure, le ragioni dell’accaduto sono altre? Certo è che la vita di Giacomo Savelli non sarà affatto tranquilla, ma si trasformerà in un’odissea di misteriosi e tragici eventi che lo trascineranno, attraverso un malvagio effetto domino, verso scoperte sconvolgenti… ma che gli faranno anche conoscere delle persone straordinarie. Un thriller che tiene ancorato il lettore dalla prima all’ultima pagina.
INCIPIT
Prologo
Era sveglia o stava ancora vivendo quel terribile incubo?
Non riusciva a vedere nulla, eppure i suoi occhi erano spalancati, ma intorno era buio totale. Forse era diventata cieca? Tremava dalla paura e dal freddo; istintivamente si massaggiò le braccia per scaldarsi un po’ e con grande sorpresa si rese conto di aver addosso solo una canottiera che la copriva fino a metà coscia. Dov’erano finiti i suoi vestiti? La felpa, i jeans… e le scarpe. Si toccò i piedi e sentì che erano impiastricciati da una specie di fanghiglia. D’impulso l’annusò: l’odore nauseabondo di escrementi le provocò un conato di vomito. Dove diavolo era finita? Cos’era quel fetore che si propagava intorno?
Si sollevò sulle gambe malferme, cercando a tentoni un punto d’appoggio, ma scivolò su un gradino viscido e cadde in un rigagnolo di liquame puzzolente. Cominciò a urlare dal dolore, dalla rabbia e dallo spavento. Singhiozzando, cercò di risalire sul rialzo di quel condotto di scarico, fino a quando le sue mani toccarono una parete. Per parecchio tempo restò seduta, addossata al muro, incurante dell’umidità che le infradiciava la schiena.
Iniziò a pregare, invocando la Vergine Santissima perché l’aiutasse a uscire da quell’inferno, ma l’angoscia tornò a manifestarsi quando temette di essere morta e di trovarsi veramente all’inferno. Com’era era finita lì? Forse per quelle orribili cose che l’avevano costretta a fare?
Immagini degradanti e disgustose presero a lampeggiare nella sua mente. Non erano ricordi nitidi, ma confuse sembianze di corpi, di volti ghignanti, di voci e parole oscene. E la sensazione dolorosa del suo corpo violato. Tutto frammentato e distorto come attraverso gli specchi di un caleidoscopio. Anche il volto di quella bambola, che l’aveva così affascinata per la dolcezza del suo viso, ora mostrava un’espressione maligna e ostile.
All’improvvisò sussultò, quando avvertì qualcosa che si muoveva sulle caviglie. Quando tentò di scacciarla avvertì un corpo peloso che le guizzò sul dorso della mano.
“Gesù! I topi!”, realizzò all’istante scattando in piedi, e subito intuì dove si trovava: nelle fogne della città. Anziché spaventarsi ulteriormente, sembrò trovare un barlume di speranza. Sicuramente l’avrebbero cercata in quel posto… Ma chi avrebbe dovuto cercarla?
Nella sua testa avvertiva una gran confusione, uno stordimento che le offuscava la capacità di rammentare cos’era accaduto. Chi era… come si chiamava? E come era finita là sotto? Provò a chiudere gli occhi concentrandosi per ricordare, ma rivedeva sempre quelle stesse immagini confuse che le rinnovavano sofferenza e nausea. Quando riaprì gli occhi ebbe l’impressione di riuscire a distinguere vagamente lo spazio nel quale muoversi, forse era solo una percezione, ma sufficiente a incoraggiarla a cercare una via d’uscita. Decise di spostarsi a ridosso della parete. Da qualche parte doveva pur condurre, pensò. Doveva solo decidere dove indirizzarsi. Dopo aver percorso un breve tratto, avvertì la pendenza del pavimento e intuì che la direzione che stava seguendo la spingeva verso il basso. Se quella dove si trovava era una fogna, sarebbe finita in qualche corso d’acqua all’aperto. Ricordò di averlo visto in un film, perciò decise di proseguire da quella direzione. Mentre procedeva a piccoli passi, sempre incollata alla parete, lanciava a tratti delle grida d’aiuto, nella speranza che qualcuno potesse udirle, e fidando che tenessero lontani i topi.
Il buio non le consentiva di valutare lo spazio percorso, né lo scorrere del tempo; l’unica cosa che percepiva era il tragitto che sembrava privo di curve. Avanzò per un lungo tratto, avvicinandosi a un punto dove sentiva l’acqua scrosciare più forte. Accelerò l’andatura, sempre badando a non perdere il contatto con la parete.
Un paio di volte rischiò di scivolare sul lastricato viscido, ma si riprese agevolmente evitando di ruzzolare nel canale di scolo.
Sentiva lo scorrere dell’acqua vicinissimo. Lo avvertiva alla sua sinistra sul lato della parete, ma anche di fronte a lei. Accelerò l’andatura, ma si bloccò di colpo quando le venne a mancare il contatto con il muro e sentì l’acqua fluire sui piedi. Lo stretto pavimento che fiancheggiava il condotto di scolo sembrava interrompersi improvvisamente.
Dopo un istante di smarrimento, arretrò di qualche passo fino a ritrovare il contatto con la parete. Verificò, a tastoni, fin dove il muro formava un angolo retto, proseguendo lateralmente: non altrettanto il pavimento, che non continuava da nessuna parte. Provò a saggiare lo spazio col piede, ma lo sentì affondare nell’acqua senza trovare punti di sostegno.
Presa dallo sconforto, si accasciò a terra, cedendo nuovamente alle lacrime, ma capì presto che era più conveniente cercare una soluzione, piuttosto che piangere.
Il fragore dell’acqua che sentiva davanti a sé, bastò a farla desistere dall’avventurarsi oltre. Avrebbe potuto attraversare il condotto di scolo che aveva fiancheggiato fino a quel punto, e provare se sull’altro lato la pavimentazione seguiva la parete. Ma scartò anche questa opportunità. L’idea di attraversare quello scolo pieno di liquami, e il timore di finire in situazioni peggiori, la fece desistere. Non restava che tornare indietro.
Mentre risaliva, venne assalita da brividi di freddo in tutto il corpo. Aveva la gola secca e cominciò ad avvertire anche i morsi della fame. Da quanto tempo non mangiava e non beveva? Cercò di non pensarci, concentrandosi sul tragitto, tentando di capire se avesse raggiunto o superato il punto dove aveva ripreso conoscenza, ma non c’era niente in quel cunicolo senza luce che potesse farle capire quanta strada aveva percorso. Fu quando avvertì che la parete stava segnando un’ampia curva alla sua destra, che comprese di aver superato la zona di partenza. Ormai procedeva per forza d’inerzia, su quello che sembrava un selciato sconnesso. Più di una volta i suoi piedi urtarono dei corpi estranei procurandole escoriazioni, ma lei non se ne curò, continuando la sua marcia cieca.
Improvvisamente intravide un chiarore non molto distante da lei, una tenue lama luminosa poco al di sopra del livello del suolo. Avrebbe voluto correre verso quel chiarore, ma la stanchezza le consentì solo di avvicinarsi a fatica. Quando finalmente raggiunse quella luce quasi crepuscolare, vide che filtrava sotto una porta di metallo. Si arrampicò con difficoltà sopra due scalini e prese a colpire rabbiosamente la porta, fino a farsi sanguinare le nocche delle dita. Provò anche a invocare aiuto, ma quelli che uscirono dalla sua bocca erano poco più che rauchi sussurri. Accostò l’orecchio alla porta fredda e umida per sentire se c’era qualcuno dall’altra parte: nessun suono di voci, né rumori. Ma se c’era una luce accesa, qualcuno prima o poi sarebbe tornato in quell’ambiente, doveva solo pazientare e restare vigile per percepire il minimo segno di una presenza. Cercò a carponi, tastando il terreno, per trovare un sasso o qualcosa per colpire quella porta con maggior forza, facendo più rumore possibile. Ma mentre era impegnata nella ricerca, la luce si spense e fu nuovamente buio completo.
Stremata, si rannicchiò a ridosso della porta, arrendendosi al torpore che la stava avvolgendo. Non reagì nemmeno quando due ratti si arrampicarono sulle sue gambe. Che male avrebbero potuto fare due topolini, a una povera fanciulla come lei?
I – Il funerale
È ineluttabile.
Non riesco a partecipare al dolore e alla mestizia di un funerale. È un fenomeno che prevarica ogni mio proposito di adesione al triste evento.
Regolarmente vengo distratto da insignificanti particolari che catturano la mia attenzione, proiettandomi in elucubrazioni irrazionali totalmente estranee alla circostanza.
Al momento stavo appunto valutando l’inutilità delle quattro maniglie poste ai lati della bara che, sontuose nella loro forma barocca, spiccavano sul legno come alfieri in parata. Solenni, eleganti, ma inutili.
Nelle due occasioni in cui avevo partecipato al trasporto del feretro, avevo ricevuto dai becchini la raccomandazione di non afferrare la bara per le maniglie, se non volevo che queste mi rimanessero in mano facendo precipitare a terra la cassa. Perché allora applicare una cosa che non serve? Una decorazione? Qualcosa in più, tanto per alzare il prezzo? O l’ultima espressione di vanità, suggerita dagl’impresari di pompe funebri ai congiunti del defunto, giustificandola con la frase: “Per dare la giusta dignità alla salma”.
Se quella era veramente la funzione delle maniglie, era logico che attirassero la mia attenzione: stavano dando dignità alla salma.
Tutti i meriti e l’onorabilità del defunto nella sua vita terrena sarebbero stati vanificati senza quelle quattro maniglie d’ottone.
Conformismi legati al triste evento. Molto spesso insinceri, esagerati, a volte ridicoli o inadatti. Come la recente, discutibile usanza di applaudire la bara al suo passaggio. Un ultimo applauso era certamente in armonia per una persona dello spettacolo, ma diventava grottesco in molti altri casi.
Applaudire il feretro di un giovane schiantatosi con l’auto, correndo a 200 km orari dopo una serata da sballo in discoteca era, a mio parere, decisamente fuori luogo. Invece di acclamare, sarebbe stato più logico urlare: “Imbecille! Avevi tutta una vita da goderti!”.
Per non parlare dei candidi palloncini lasciati volare in cielo.
Scoprii questa mia tendenza a vagheggiare in occasione della scomparsa di mio padre.
Avevo da poco compiuto sedici anni quando il poveretto morì per un incidente sul lavoro. L’appartamento dove abitavo con la mia famiglia, si era trasformato in un porto di mare. I quarantacinque condomini dello stabile, appresa la notizia nel vedere mezzo portone chiuso a lutto, si avvicendavano in casa per porgere le condoglianze e consolare mia madre, impegnata in angosciosi ululati tra uno svenimento e l’altro. A ogni suo deliquio, i presenti si agitavano come forsennati alla ricerca di aceto o ammoniaca da farle annusare. Così, dopo quattro o cinque malori, mia madre preferì desistere per non ritrovarsi con il naso ustionato dai pestiferi vapori.
Tutto mi appariva teatrale ed eccessivo. Come l’atteggiamento assunto da mio fratello. Lui, maggiore di dieci anni, tentava maldestramente di assumere il ruolo del nuovo pater familias, con l’incoraggiamento e il conforto di amici e conoscenti.
Una situazione decisamente farsesca. Il meschino, riusciva a malapena a badare a se stesso e alla sua giovane moglie. Ma indubbiamente questo nuovo onere sembrava ripagarlo dell’anonimato nel quale era immerso da sempre.
In modo bizzarro, la tragedia ci aveva di colpo reso protagonisti, collocandoci al centro della scena, ed avevo inconsciamente l’impressione che questo ci ripagasse in parte della dipartita paterna.
Senza dubbio mi gratificò la signorina Lucia, la pettoruta valchiria dell’interno 15, oggetto del desiderio dell’intero stabile, quando mi abbracciò spingendo la mia testa tra i suoi seni, sollecitandomi a dar sfogo al mio dolore. Una simile opportunità valeva bene alcuni falsi singhiozzi, pur di prolungarne la durata. Mi scostai da lei a malincuore solo per il timore che l’erezione provocata da quell’abbraccio diventasse troppo evidente.
L’imprevedibile sciagura mi aveva scaraventato in una sorta di limbo, dove tutto mi appariva vago e irreale, tanto da non riuscire a provare alcuna sofferenza o dispiacere.
Quando vidi il corpo di mio padre, composto nella camera mortuaria dell’ospedale, non provai alcuna emozione. Mi colpì piuttosto l’aspetto trascurato di quella sala, dalle pareti scolorite e crepate in alcuni punti. Le macchie d’umidità sul soffitto e quell’odore singolare che, anche se mai avvertito prima, identificava la morte.
Anche il comportamento di mia madre, che continuava ad accarezzare quel gelido volto, sussurrandogli parole affettuose, alternandole a lamentosi rimproveri per averla abbandonata, invece di commuovermi m’infastidiva.
Ero insensibile di fronte all’immobilità di quel corpo, che faticavo a identificare con colui che era stato mio padre.
Avrei dovuto soffrire almeno un poco, invece niente.
Mi domandai se, quando era in vita, l’avessi amato. Riconobbi che vere manifestazioni d’amore non c’erano state. Al massimo, reciproca benevolenza.
Ma ciò che maggiormente m’impediva di affliggermi era la sua immobilità.
Mi suscitava tenerezza tutto ciò che era vita, suoni, colori, profumi, ma soprattutto il movimento. Ritenevo che il moto e l’azione fossero originati e posseduti da un’anima, quindi capaci di generare amore o sofferenza.
L’immobilità non mi provocava alcuna emozione.
Spicciola filosofia adolescenziale, per mascherare la mia incapacità a commuovermi in un simile frangente. L’amarezza maturò in solitudine, qualche tempo dopo. Purtroppo, senza il conforto della super dotata signorina Lucia.
Nei trent’anni seguenti, ho partecipato a diversi funerali. Quello di mia madre, di mio fratello, o quelli di semplici conoscenti. In ogni circostanza, nonostante i migliori proponimenti, la mia partecipazione non è andata oltre una formale compostezza esteriore. Evidentemente la mia elaborazione del lutto ha tempi separati dal rito funebre.
Il funerale della zia Tilde non fece eccezione alla regola.
La chiesa di Santa Maria Infraportas, a Foligno, era gremita di gente. La zia Tilde era persona nota e benvoluta. Molte erano le persone che le dovevano riconoscenza, non ultimo il sottoscritto.
Ma invece di struggermi per la sua improvvisa dipartita, la mia attenzione era rivolta, dopo le maniglie della bara, alle armoniose curve delle natiche di mia cugina Viola, che sembravano volersi liberare dalla costrizione di una gonna troppo aderente. Quasi non bastasse, ogni volta che il rito imponeva di alzarsi in piedi, Viola lisciava sensualmente improbabili pieghe del tessuto. Seduto dietro di lei, avrei tanto voluto farmi carico di quell’oneroso gesto.
Poi fu la volta del mio vicino ad attrarre la mia attenzione. Costui continuava a sistemarsi la manica della giacca per assicurarsi che le due etichette cucite sul bordo, “PURA LANA VERGINE” e “RIFINITO A MANO”, risultassero bene in mostra.
Forse l’unico momento di partecipazione fu quando venni invitato dal celebrante a leggere il Salmo 23. Ma, mentre declamavo quei versi, mi parve udire i commenti di qualcuno dei presenti nelle prime file:
– Ma chi è quello che legge?
– È da tanto che non si vede più in televisione…
– Dicono che adesso fa lo scrittore. O il regista? … boh!
– Certo che è un gran bel ragazzo!
– Più che ragazzo, un uomo. Deve aver superato la quarantina.
– Eppure non li dimostra. Chissà quante femmine gli gireranno attorno?
– Figurarsi… Le attrici… Tutte mignotte…
– Ma non s’è mai sposato?
– Non mi pare, ma a che gli serve una moglie?
– Giusto. Con tutte le attrici che conosce…
– … tutte grandissime mignotte!
Terminata la lettura, riguadagnai la mia postazione, dedicandomi a osservare l’interno della chiesa, dove una nutrita schiera di Madonne con Bambino decoravano le navate laterali, alternate a immagini di santi, crocifissioni e scene della passione di Cristo.
Al termine della cerimonia, una processione di gente venne a rinnovare il proprio cordoglio a Viola e a me, unici parenti superstiti della cara estinta.
A mia cugina vennero riservate le espressioni più strazianti e formali. A me congratulazioni per la lettura dei brani, complimenti per il lavoro e anche una richiesta d’autografo che declinai promettendo l’invio di una foto con dedica.
Vennero a salvarci da quella fiera di simulate afflizioni gli addetti al servizio funebre, che ci sollecitarono per la tumulazione della salma.
Quando tutte le pratiche vennero espletate e la zia Tilde poté riposare in pace insieme a suo marito nella tomba di famiglia, Viola m’invitò a casa sua. Voleva cambiarsi d’abito prima di andare a cena.
Mia cugina abitava in un graziosa villetta indipendente in una zona poco fuori città, unica consolazione rimasta dopo un matrimonio fallito.
L’interno della casa, arredato in maniera sobria e funzionale, era decisamente confortevole. Un trascurabile disordine donava all’ambiente quel giusto tono di “vissuto” che aveva il pregio di renderla accogliente. Del resto, una donna in carriera qual era Viola, poteva dedicare alla casa ben poco tempo.
– Mettiti pure comodo, intanto che mi cambio. Nel frigo c’è una bottiglia di Orvieto aperta e del tè freddo. Se hai bisogno del bagno sai dov’è… Insomma, fa quello che ti pare… – concluse salendo rapidamente le scale che portavano alle due camere da letto, al piano superiore.
M’abbandonai sul divano e socchiusi gli occhi.
Era ormai quasi sera e i colori del tramonto filtravano attraverso l’enorme finestra del soggiorno. La stanchezza di una giornata alquanto stressante iniziava a farsi sentire, dopo tre ore di viaggio in auto da Roma e tutte le fastidiose formalità del funerale.
In quello stato di totale abbandono, presero a fluttuarmi nella mente immagini del passato.
Viola e le vacanze estive a Foligno.
Viola e le lunghe passeggiate in bicicletta.
Viola e i bagni nel fiume, in compagnia di un terzetto di amici chiassosi e simpatici. Viola e i pomeriggi al cinema Lux, dove assistevamo due volte allo stesso film.
Fino all’indimenticabile estate del ‘78 quando, grazie a Viola, scoprii le delizie del sesso. Avevamo compiuto da poco quattordici anni e, nonostante l’imperizia della prima volta, fu un’esperienza sublime e poetica. Senza alcun imbarazzo, Viola mi guidò dentro di lei, favorendo amabilmente la mia inesperienza erotica.
Nei giorni seguenti fu tutto un ricercare, un curiosare e un inventare per migliorarci nell’arte amatoria.
Terminata la vacanza, il mio rientro a Roma fu a dir poco drammatico: avevo bevuto e ora conoscevo la sete, ma spegnere quell’arsura non era cosa facile per un ragazzo adolescente, senza alcuna amicizia femminile.
Quella fu la mia ultima estate a Foligno.
Non seppi mai se le rispettive famiglie avessero sospettato qualcosa o se, per un improvviso benessere economico che investì la mia famiglia, mio padre decise l’anno successivo di cambiare località di villeggiatura. Quel cambiamento non fu per lui di buon auspicio: l’estate seguente, invece della villeggiatura ci fu il suo funerale.
– Cosa sta sognando di bello il mio cuginetto? – domandò Viola prendendomi il viso tra le mani.
– Niente di speciale – le risposi mentendo spudoratamente.
– Non ne sono convinta. Avevi un’aria sognante e paradisiaca.
– Ho sempre un’espressione serafica quando mi rilasso.
– Che ne dici di un aperitivo, prima di cena?
– Perfetto. Quell’Orvieto che mi avevi proposto sarebbe l’ideale.
– Aggiudicato l’Orvieto – sentenziò mentre spariva in cucina.
Tornò poco dopo con il vino, i bicchieri e un vassoio di salatini. Indossava un tailleur pantalone verde scuro, altrettanto seducente dell’abito che vestiva in chiesa.
– Raccontami di te. È cambiato qualcosa negli ultimi due anni? – le domandai.
– Niente di speciale. La solita vita di provincia. Casa, lavoro e il week-end con gli amici – rispose mentre versava il vino.
– Quando salirai ai piani alti della banca?
– Non ci penso proprio. Mi basta la direzione di filiale. Vita tranquilla, anche se monotona. Ogni tanto capita qualche buon affare, giusto per rinverdire gli allori e mantenermi nel mio guscio dorato. Mi va bene così. Tu piuttosto, ho saputo che hai abbandonato le scene?
– Più o meno. La vita dell’attore è alquanto impegnativa. Se non sei divorato dal sacro fuoco della recitazione, il tutto si riduce a fatica e disciplina.
– Sempre il solito insofferente e… ingrato.
– Se ti riferisci a zia Tilde che ha finanziato i miei studi all’Accademia d’Arte Drammatica, hai ragione solo in parte. Credo di averla ripagata con qualche successo teatrale e una decina di fiction televisive di buon livello. Ma la televisione non è affidabile: dalle stelle alle stalle in un battito di ciglia. Il teatro offre maggiori soddisfazioni, ma non ti garantisce gli stessi guadagni e richiede sacrificio e impegno più consistenti.
– Cinema?
– Per carità! Mi è bastata la televisione…
– Quindi?
– Rimanendo nell’ambito dello spettacolo, trovo più conveniente fare l’autore. Minor impegno, nessun orario e guadagni soddisfacenti. Se proprio ho voglia di recitare, posso sempre riservarmi un cammeo.
– Un cammeo? – domandò divertita.
– Una piccola parte in un ruolo importante.
– Come può essere importante, se è una piccola parte?
– Ma perché lo interpreto io – risposi con enfasi.
Viola rise divertita.
– E adesso a cosa stai lavorando?
– Alla stesura di un musical.
– Bello! e di cosa tratta?
– Top secret.
– Dai!… una piccola anticipazione – sollecitò con voce infantile.
– Non se ne parla proprio! Non sai che la gente di teatro è tremendamente superstiziosa?
– Sapevo degli attori.
– Anche i produttori, i registi, gli scenografi e soprattutto gli autori.
– Basta, sono arrabbiata… non ti voglio più bene – concluse assumendo un aria da fanciullina offesa e contrariata.
– Quando mai me ne hai voluto?
– Ma che vai dicendo? Se sei il mio cugino preferito! – replicò vivacemente.
– Anche perché sono l’unico.
Questa mia frase rese Viola improvvisamente seria e pensierosa.
– Hai ragione. Riflettendoci, noi due siamo rimasti i soli superstiti dei Savelli.
– Vorrai dire che io sono l’unico superstite.
– Io sono una Savelli per parte di madre.
– Non è la stessa cosa. Il cognome è ciò che conta, e l’ultimo dei Savelli sono io – commentai teatralmente.
– Non scherzare. È triste pensare come tutti i nostri familiari siano scomparsi abbastanza precocemente. Giusto la zia Tilde può considerarsi un’eccezione.
– Ottantanove anni sono un’età rispettabile, sei d’accordo? – sottolineai.
– Non può certo rimpiangere nulla. Ha vissuto intensamente la sua esistenza e si è spenta nel migliore dei modi. Dormendo.
– È il massimo che si possa desiderare – conclusi cercando di dare un taglio a quel discorso, cosa che Viola avvertì al volo.
– Lasciamo perdere questi discorsi! Penso che per oggi abbiamo elargito più che abbastanza alla tristezza – disse alzandosi in piedi. – Ascolta, ti preparo la stanza, prima di andare a cena?
– Veramente avevo pensato di andare in albergo.
– Perché in albergo?
– Beh… Il paese è piccolo, la gente mormora… – borbottai, cercando di riportare la conversazione su toni più leggeri.
– Non essere stupido, ormai anche qui non mormora più nessuno. Sono ben altre le cose sulle quali la gente mormora, sicuramente più piccanti di un cugino ospite in casa mia.
– I peccati segreti di Foligno – dissi in tono tenebroso.
– Molto più di quanto tu possa immaginare. E a proposito di segreti, ricordami che domani devo telefonare al notaio Corsico per sapere quando è prevista l’apertura del testamento della zia.
– Perché, c’è un testamento? – domandai meravigliato.
– Tu pensi che la zia Tilde fosse il tipo da morire intestata?
– Per la verità, non ci ho pensato minimamente. Il pensiero di un testamento non mi ha neanche sfiorato – aggiunsi con sincero stupore.
– Allora preparati a qualche sorpresa.
– Del tipo?
– Top secret! I direttori di banca sono come gli autori teatrali.
– Posso sempre provare a indovinare.
– Provaci.
– La casa qui a Foligno, dove abitava… – iniziai a elencare, ma subito mi resi conto di non trovare altro.
– Poi? – sollecitò Viola
– … poi… poi… Ah sì, l’uliveto vicino a Spoleto. Ma vale qualcosa?
– Quasi 200 piante! Tu che dici, vale qualcosa?
– E che ne so, non faccio il contadino.
– Appunto… sei un topo di città… Poi cos’altro possedeva?
– Non ho idea. Immagino abbia avuto qualche risparmio?
– Qualche risparmio? Se vogliamo usare un eufemismo, possiamo chiamarlo così. Solo quanto è depositato presso la mia filiale, tra titoli al portatore, BOT e CCT, ti sorprenderà. E non escludo che esista qualcosa presso altre banche. Senza scartare la possibilità di eventuali conti all’estero. Infine, hai dimenticato il fondaco e la casa del Borgo.
– Giusto! – ricordai. – Quella che lei chiamava “la Porziuncola”.
– Esattamente. Anche se della porziuncola aveva solo il nome.
– Mi sono sempre chiesto perché mai avessero acquistato quella casa, dove ci andavano solo qualche fine settimana.
– È stato più un capriccio dello zio Adelmo, molti anni fa. Sosteneva che l’aria del Borgo era più salubre di quella di Foligno. Quella casa gli piaceva perché era all’estremità del paese, nel punto più alto, dove non avrebbero mai potuto costruirci altre case. E così, come lui era solito dire, avrebbe potuto pisciare in testa a tutti i compaesani.
– Ora che me lo dici, mi ricordo. Lo zio Adelmo era nativo di Borgo e da giovane, se rammento bene, in paese l’avevano sempre considerato un incapace, una persona senza spina dorsale.
– L’acquisto di quella casa fu una sua rivalsa sui paesani e sulle loro malignità – concluse Viola.
Dopo un attimo di riflessione le domandai:
– Mi chiedo come abbiano fatto la zia Tilde e lo zio Adelmo ad accumulare una simile fortuna con un bar pasticceria.
Viola mi fissò inorridita per alcuni istanti, come se avessi equiparato il santuario di Lourdes alla Pieve del villaggio.
– Giacomo, non essere blasfemo! Quella della zia era “La Cioccolateria Savelli”, un mito in tutta la regione. Il tempio della prelibatezza, la Treccani del manicaretto, il Bolaffi della leccornia.
Ancora oggi, dopo diciotto anni che la zia ha ceduto la sua attività, la cioccolateria Savelli gode della stessa fama e prestigio, anche se la clientela più anziana sostiene che il livello qualitativo non sia più lo stesso di quando c’era la zia Tilde: eccellente, ma non fa più sognare.
– Personalmente l’ho sempre considerata una buona pasticceria, senza il florilegio di qualità che ne hai fatto. Però, non era lo zio Adelmo l’artefice di tutte quelle ghiottonerie? – domandai
– Erano un binomio perfetto, un’accoppiata vincente – precisò Viola. – Lo zio dietro le quinte e la zia sulla scena. Lui con la sua ricerca, quasi maniacale, delle novità dolciarie e gastronomiche. Con le sue ricette segrete, che da sole dovevano valere una fortuna. Lei, con un savoir fairedegno di un diplomatico, gestiva le pubbliche relazioni con una grazia e una disinvoltura uniche. Ogni cliente, dall’operaio al sindaco, venivano trattati con la stessa attenzione e riguardo, come se fossero i clienti più importanti. Sapeva passare dal confidenziale all’ossequioso con leggiadria e spigliatezza. Favorita, non dimentichiamolo, dalla sua prorompente bellezza, che in qualche caso ha suscitato la gelosia dello zio.
– Lo zio Adelmo geloso? – domandai sorpreso.
– Lo era, anche se non lo dimostrava. Sapeva esserlo in maniera sottile, discreta. Ma anche la zia Tilde non scherzava, specie quando lui si assentava per le sue trasferte all’estero, alla ricerca di novità gastronomiche.
– È per questo che negli anni “La Cioccolateria” aveva mutato orientamento, privilegiando la gastronomia?
– Sempre per merito della zia Tilde. Era una donna particolarmente attenta ai segni dei tempi. Aveva capito che la sua clientela non si rimpinzava solo di dolciumi.
– Incredibile! Sono veramente sorpreso per quanto mi stai raccontando! Sei una vera enciclopedia di famiglia – esclamai meravigliato.
– Non sorprenderti. Interessarsi degli affari altrui è l’attività più diffusa della provincia.
– Ti confesso che ignoravo quasi tutto ciò che mi stai rivelando. Una storia di famiglia veramente intrigante. Continua…
– Magari a cena. È ora di andare, prima che l’Orvieto ci seghi le gambe.


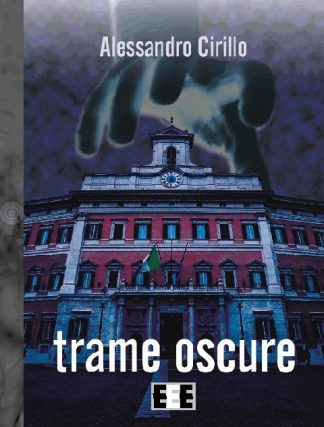



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.