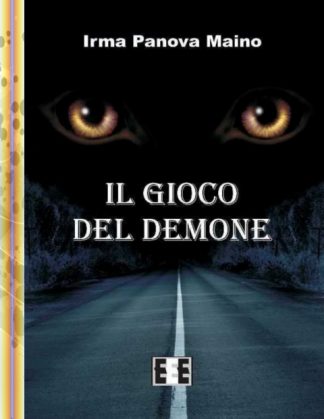Descrizione
Daniele è un single di quasi quarant’anni, un uomo come tanti, con una vita banale. Durante il funerale della nonna, al cimitero, il suo sguardo cade all’improvviso sulla fotografia di una giovane donna, Lucrezia Vannini, morta molti anni prima. Ne rimane immediatamente affascinato. Ma, se la donna è davvero morta, perché può vederla e parlarle? Daniele inizierà un cammino unico e straordinario, colmo di emozioni sorprendenti che lo porteranno al di là dei limiti della vita stessa. L’amore oltre le catene del tempo è la storia di un amore singolare, di un sentimento profondo e assoluto, che ha tutte le caratteristiche del sogno e la tragicità di una condanna.
INCIPIT
Capitolo 1 – Nonna Claretta
Lo squillo del telefono mi svegliò. Lentamente mi misi seduto e mi passai le mani sul viso nel tentativo di riprendermi più velocemente dall’intontimento. Stanco, cercai di mettere ordine nei pensieri. Mi ritrovai sul divano di casa dove mi accorsi di essermi addormentato vestito, la sera prima. La bottiglia di vino rosso quasi vuota sul tavolino di fronte mi aiutò a ricordare che evidentemente avevo cercato, invano, di annegarvi il mio dolore. Mentre il telefono continuava fastidiosamente a squillare, sbirciai il nome sul display. A quel punto cominciai a ricordare perché mi ero scolato quasi tutta la bottiglia prima di crollare sul divano. Scrollai la testa un po’ dandomi dello stupido e un po’ per la situazione. Per la verità ero in attesa di quella telefonata da un momento all’altro. Presi il telefono e, con gli occhi semichiusi, risposi e ascoltai in silenzio le parole di mia madre, troppo veloci e dispositive, vista la circostanza. Annuii con monosillabi impastati a ogni sua domanda o a ogni suo ordine. Mormorai qualcosa che nemmeno ricordo. Poi la salutai, chiusi la telefonata mentre lei ancora stava parlando e, dopo aver buttato il telefono accanto a me, sul divano, mi sdraiai nuovamente cercando di riprendere il riposo che avevo interrotto bruscamente, ma non riuscii ad addormentarmi in fretta come la sera prima, anzi, non ci riuscii proprio. Avevo bisogno di una doccia, non calda, per riprendermi alla svelta. Mi guardai distrattamente attorno come se stessi cercando qualcosa. Per la prima volta mi resi conto di quanto potesse essere disordinata la casa di un single. Respirai. Vivevo da alcuni anni in un bilocale all’ultimo piano di una palazzina immersa nel verde. Lo avevo arredato in maniera disordinata, come disordinata era stata la mia vita fino a quel momento. Alle spalle del divano su cui ero ancora seduto avevo voluto una libreria alta fino al soffitto.
Ci avevo stipato tutti i libri che avevo letto.
Amavo leggere.
Il pavimento era in parquet chiaro e contrastava con il colore scuro del legno della libreria e del mobile più basso che avevo disposto di fronte al divano. Mi accorsi che la mente non era più offuscata dal vino perché saettò immediatamente indietro nel tempo, libera e leggera, a quando, da bambino, passavo alcune settimane di vacanze dai nonni in campagna.
Ora che anche la nonna non c’era più, mi sentivo davvero solo. Era una condizione nuova, per nulla piacevole, che mi mordeva allo stomaco e mi pesava sul cuore. La notizia che annunciava la sua morte non era arrivata inattesa. Tuttavia, non ero preparato e per questo avevo tentato stupidamente di stordirmi cercando rifugio nella bottiglia di vino che ora era lì, davanti a me. La morte della nonna mi aveva lasciato dentro una sensazione di solitudine che non avevo messo in conto. Non ero pronto a quel lutto, non lo sarei mai stato. Non mi rimanevano che i ricordi. «Ben poca cosa se confrontati a lei, viva, al suo sorriso e alla sua bontà. Tutto quello che mi aveva detto, tutto quello che avevo fatto con lei, tutti i momenti trascorsi a casa sua erano qui dentro, custoditi nel mio cuore e nella mia mente» mormorai tra me portandomi la mano al petto. «Le persone che amiamo non muoiono mai. Inoltre, essere figlio unico non è un gran vantaggio quando si perdono per sempre i punti di riferimento affettivi più importanti» pensai, sentendo forte la mancanza di un fratello o di una sorella. Mi sentivo solo, tremendamente solo.
All’improvviso avrei voluto avere accanto una persona da abbracciare, con la quale parlare o anche rimanere in silenzio, una donna da stringere e con la quale condividere magari un bicchiere di vino.
Mia madre non avrebbe mai potuto sostituire i nonni, non lo aveva mai fatto nemmeno quando erano vivi.
I ricordi legati al periodo delle vacanze trascorse con loro sarebbero rimasti in assoluto i più belli della mia adolescenza e forse della mia vita fino ad allora vissuta.
Dopo tanti anni erano ancora lì, indelebili, e ora li avrei custoditi con maggiore cura perché ero certo, sbagliandomi, che non se ne sarebbero aggiunti altri. Mentre mi alzavo dal divano e mi trascinavo in bagno, mi sembrava di vederla, nonna Claretta, venirmi incontro chiamando il mio nome fino al momento in cui, correndo, la raggiungevo e poteva finalmente tenermi stretto tra le sue braccia. Solo in quel momento, così magico e così normale, per un bambino di pochi anni, mi sentivo davvero in vacanza. Quel piacere si era reiterato anche in tempi più recenti, anche se non ero più un bambino e quasi non riusciva più a stringermi completamente in un solo abbraccio.
Toccava a me abbracciarla, facendo attenzione a non metterci troppa forza.
Indugiai un attimo davanti allo specchio: dentro ero ancora quel bambino, fuori ero un uomo maturo di quasi quarant’anni. Mi mancavano i suoi abbracci e ora mi sarebbero mancati ancora di più. Mi spogliai e aprii l’acqua facendo attenzione a mantenerla appena tiepida. Mi toccai i capelli corti, cortissimi, e indugiai prima di lasciare che l’acqua scivolasse sulla mia pelle. «Dovrei radermi» pensai passandomi una mano sulla guancia. Non volevo presentarmi al funerale con il viso in disordine.
Il nonno non era quasi mai lì ad aspettarmi quando arrivavo. Mio padre parcheggiava l’auto sull’aia, sempre nello stesso punto, quasi ci fossero delle righe disegnate sul cemento che scorgeva solo lui, e io dovevo attendere che spegnesse il motore per poter aprire la portiera. Nonno Palmiro era sempre affaccendato e io non vedevo l’ora di raggiungerlo perché sapevo benissimo che anche lui mi stava aspettando.
A nulla servivano i rimbrotti di mia madre che pretendeva, urlando, che mi cambiassi le scarpe o almeno i pantaloni prima di raggiungere il nonno. Appena fuori dalla macchina salutavo la nonna e poi correvo via, veloce come il vento e incurante delle urla di mia madre.
Nonno Palmiro non era il mio vero nonno. Mia nonna lo aveva sposato, in seconde nozze, nell’estate del 1947, dopo che era stata confermata la triste notizia che il suo primo marito era morto nella disastrosa Campagna di Russia.
L’acqua era calda. Girai un poco la manopola perché avevo bisogno di acqua appena tiepida. Sospirai.
Poteva essere per campi o nell’orto, poteva essere nella stalla a badare alle mucche o dietro la casa a pulire le gabbie dei conigli ma, qualsiasi cosa stesse facendo, sapeva che tra poco l’avrebbe fatta con me. Anni dopo venni a sapere da mia nonna che spesso nonno Palmiro accumulava alcune faccende nei giorni a ridosso del mio arrivo. Era il suo modo per darmi il benvenuto. Sapeva quanto ci tenessi ad aiutarlo nei suoi lavori: vangare l’orto, pulire le gabbie degli animali, strappare le erbacce e raccogliere le uova appena deposte. Lui sapeva quanto mi piacesse sporcarmi le mani con la terra. Ne adoravo l’odore quando era arsa dal sole, così come dell’erba appena tagliata. Odori unici che rimangono stampati dentro.
Diventavo la sua ombra, garzone silenzioso e riflessivo come lui. Ricordo che durante i primi anni i miei genitori si fermavano per la notte. Successivamente, iniziarono a fermarsi solo per il pranzo o la cena e, poi, a seconda dell’ora di arrivo, solo il tempo di un saluto veloce.
Le scuse che di volta in volta presentavano ai nonni erano sempre poco verosimili, ma a nessuno, tanto meno ai nonni, interessava approfondirne la verità.
Io ero felice di essere lì e loro erano felici di avermi con loro fino alla fine dell’estate. Non saprei dire se i miei nonni avessero mai compreso il tipo di rapporto esistente tra i miei genitori. A volte avrei voluto chiederlo, ma sempre, puntualmente, un groppo pesante e ingombrante mi saliva dallo stomaco e si piazzava in gola quasi ad avvertirmi che sarebbe stato meglio ricacciarlo giù in fondo, da dove era nato e dove era meglio che stesse. Non volevo chiedere perché non volevo ascoltare la loro risposta, ma credo che sapessero quasi tutto o, almeno, quello che era importante sapere. Del resto, sapevano fin troppo bene quanto fosse caratterialmente impegnativa mia madre e caratterialmente sottomesso mio padre.
Il rumore dell’acqua della doccia mi avrebbe impedito di sentire ogni tipo di rumore. Mi buttai sotto e ricominciai a pensare. Appoggiai le mani alla parete, abbassai la testa lasciandomi colpire dall’acqua sulla nuca e chiusi gli occhi.
Nonno Palmiro non amava parlare molto, anzi parlava davvero poco, ma a me andava benissimo così. Ci capivamo al volo senza bisogno di tanti giri di parole. Mi bastava una sua occhiata o una sua smorfia sotto gli enormi baffi grigi e io capivo esattamente cosa dovevo o non dovevo fare.
Dei periodi di vacanza legati ai miei primissimi anni non ho ricordi precisi. Più che altro sono solo frammenti di vita, raccontati dai miei genitori o direttamente dai nonni, avvenimenti che quasi non mi appartengono davvero, quasi fossi stato spettatore della vita di qualcun altro.
Ho cominciato a trascorrere da solo le vacanze dai nonni dopo i sette anni, probabilmente perché da quella età si diventa più responsabili o più semplicemente perché i miei genitori non vedevano l’ora di starsene un po’ da soli senza avermi continuamente tra i piedi. Non l’ho mai saputo e non l’ho mai chiesto.
Di quel tempo, dopo i sette anni, invece, ricordo tutto: l’arrivo, la mia permanenza e, purtroppo, la partenza. In mezzo c’era tutta la vacanza che io cercavo di far durare il più possibile perché temevo sempre che potesse essere l’ultima.
Appena mio padre fermava l’auto e spegneva il motore, scendevo, richiudevo la portiera alle mie spalle e respiravo profondamente, estasiato dagli odori a me familiari. Mi sentivo davvero a casa solo lì, era come se avessi un cordone ombelicale invisibile che mi teneva collegato ai nonni e a tutto quello che girava intorno a loro.
Venivo investito da una moltitudine di profumi che significavano per me cose ben precise, come il grano a seccare sull’aia, il temporale in arrivo e quindi l’odore della pioggia o le gabbie dei conigli da pulire. In fondo al mio cuore di bambino sapevo che prima o poi qualcuno mi avrebbe destinato a vacanze diverse. Ogni volta che quel pensiero mi investiva, ogni anno in maniera più opprimente, avvertivo una sensazione strana, come se qualcosa tentasse di soffocarmi. Non volevo rinunciare alle mie vacanze, ma, soprattutto, non volevo rinunciare ai nonni. Palmiro e Claretta erano i miei nonni materni, anche se non ritrovavo nulla in mia madre che potesse ricordarmeli. Così come io non assomigliavo nel fisico e nel carattere ai miei genitori, lei non assomigliava al suo papà e alla sua mamma. A volte dimenticavo che mai avrei potuto trovare somiglianze tra mia madre e il nonno o tra me e nonno Palmiro, non essendo davvero suo padre e, quindi, il mio vero nonno. Poco o nulla sapevo dei nonni paterni, se non che erano morti quando mio padre era poco più di un ragazzo.
Nemmeno a cercarlo, avrei trovato un filo d’argento tra i capelli lunghi e neri di mia nonna. Li teneva raccolti perennemente in una crocchia, quasi li volesse proteggere dal vento o preferisse far risaltare gli occhi verdi e il sorriso rassicurante come un abbraccio caldo. Un pomeriggio, mentre giocavo alla ricerca di un tesoro immaginario in soffitta, dentro un vecchio mobile, credo fosse un baule, trovai in una scatola di latta scolorita alcune fotografie in bianco e nero di un giovane con i capelli scuri e gli occhi che parevano chiari come i miei.
Una fotografia lo ritraeva accanto a un cavallo, una lo ritraeva in bicicletta e una accanto a un ragazzo pressappoco della sua età: sorridevano entrambi. Sembravano felici. Credo che l’altro ragazzo fosse nonno Palmiro. La cosa mi piacque e mi fece sorridere, un sorriso di appartenenza, credo. Ricordo di aver sfiorato il viso di quel ragazzo sulla fotografia con le dita, nella speranza che potesse parlarmi o anche solo sorridermi. Fu una grande scoperta perché fino a quel giorno avevo sempre pensato di essere stato adottato.
Decisi di parlare con la nonna di questi miei pensieri e di quelle foto. La nonna non si arrabbiò, anzi sembrava che si aspettasse, prima o poi, che io scoprissi quella scatola e mi presentassi a lei con una serie di domande. Quel giorno mi raccontò tutta la storia. Aspettò che nonno Palmiro tornasse dai campi e insieme mi parlarono della guerra, di nonno Guglielmo e della promessa che quel ragazzo dagli occhi chiari aveva strappato a Palmiro, il suo migliore amico, prima di partire per il fronte. Mi sembrò quasi di vederli, giovani e forti, con tutto il futuro negli occhi e le speranze nel cuore. Ma la guerra faceva paura, sempre, soprattutto a due ragazzi semplici come loro che scrivevano e leggevano a fatica e che avevano sentito parlare della guerra solo dal barbiere o in chiesa, durante la Santa Messa.
«Devi promettermi una cosa!» aveva esclamato mio nonno, quello vero, prendendo per le spalle il suo amico Palmiro. L’amico era rimasto in silenzio. Guglielmo sarebbe partito per il fronte l’indomani e lui avrebbe detto o fatto qualsiasi cosa gli avesse chiesto.
«Se non dovessi tornare, promettimi che ti prenderai cura di mia moglie Claretta e di mia figlia che nascerà tra poco» aveva detto nonno Guglielmo continuando a strattonarlo per essere certo di avere tutta la sua attenzione. Palmiro si rifiutava quasi di ascoltare perché sapeva che l’amico in più di un’occasione gli aveva dimostrato di avere il cuore presago.
Mio nonno Guglielmo non poteva sapere che il figlio che sua moglie portava in grembo sarebbe stata una figlia: mia madre Angela. Non poteva saperlo, ma se lo sentiva. «Non c’è bisogno di questa promessa. Tu tornerai dalla guerra» gli aveva risposto Palmiro cercando di infondere nelle sue parole tutta la sua convinzione e la sua speranza.
«Promettilo! Promettilo!» aveva chiesto ancora, con maggiore insistenza, il nonno.
Le cose erano andate pressappoco così.
Diversamente da loro, mia madre era bionda, con occhi castani leggermente incavati e una bocca ben disegnata che raramente avevo visto distendersi in un sorriso. Le mani erano piccole e le dita perfette, diverse da quelle forti e sincere dei miei nonni, mani segnate dal tempo e dal lavoro duro e continuo nei campi. Rammento che la sera, quando ero più piccolo, mi sdraiavo sul divano e mi addormentavo appoggiando la testa sulle gambe della nonna che sedeva accanto a me. Lei aveva sempre qualcosa da rammendare: un paio di calzini del nonno, una tovaglia o un fazzoletto. Di tanto in tanto, interrompeva il lavoro di rammendo, appoggiava il dorso della mano sulla coscia e lasciava che posassi il mio viso sul suo palmo caldo e ruvido, come fosse un piccolo guanciale. Nonostante i calli e la pelle indurita dal lavoro quotidiano nei campi e nella stalla, mi sembrava un posto morbido e accogliente, il più accogliente che potessi immaginare.
Sentivo l’acqua della doccia scorrermi addosso come lacrime giganti e ricordi. Girai la manopola e chiusi il getto. Mi ero completamente ripreso. Durante le vacanze, prima di addormentarmi capitava, a volte, che pensassi ai miei genitori. Li immaginavo a casa, silenziosi, seduti distanti mentre mangiavano pietanze insipide come la loro vita, oppure al lavoro, annoiati, metodici, quasi trasparenti.
Mia madre svolgeva da una trentina d’anni il medesimo lavoro di sarta presso un famoso Teatro. Mio padre era titolare di una Società che da due generazioni importava frutta dalla Penisola Iberica per distribuirla su tutto il territorio nazionale.
Due lavori completamente diversi per due persone così simili, soprattutto nell’incapacità di donare affetto. Dei due, la vera sorpresa era mio padre. Non riuscivo a comprendere come potesse, un uomo triste e banale come lui, gestire con profitto e capacità imprenditoriali un’azienda come la sua.
A volte pensavo di essere capitato per caso nella vita di quei due individui, forse caduto dal camino o dai rami più alti di un albero come un frutto maturo e inatteso. Ero così diverso da loro: mi ritrovavo a fissare egualmente meravigliato il colore di un fiore o lo sguardo imperfetto di una donna; mi bastava un odore per collegare la mente e il cuore a una persona, a un ricordo o solo a un nome. I miei genitori sembravano invece incapaci di provare il minimo sussulto per qualsiasi cosa. Nulla sembrava in grado di colpirli, di interessarli o di farli piangere di gioia. Io li avevo sempre visti così. Chissà se era stata la vita a cambiarli, a renderli così indifferenti a tutto.
Allungai il braccio, afferrai l’accappatoio e cominciai ad asciugarmi.
Le settimane, i mesi e gli anni scorrevano senza una scossa, senza un fremito. Tutto era sempre uguale, tutto doveva scorrere su binari noti e incredibilmente noiosi. Ogni primo lunedì del mese mio padre regalava a mia madre sei rose rosse. E lei ricambiava ringraziando e baciandolo sulla guancia. Anche quel gesto, così tenero e carico di amore, se svincolato dalla realtà di casa mia, assumeva davanti ai miei occhi un significato banale, vuoto e abitudinario. Perché quei fiori? E perché sei rose rosse? Non l’ho mai saputo e non l’ho mai voluto sapere. Ogni volta mi ripromettevo che avrei preferito la solitudine o la morte, piuttosto che vivere una vita di coppia insapore come la loro.
Guardai l’ora. Dovevo prepararmi in fretta.
Abbandonai gli studi quando mi mancavano soltanto tre esami per laurearmi in Economia e Commercio, più per protesta nei confronti dei miei genitori che per una reale convinzione personale. Svolgevo già un’attività, o meglio, ne svolgevo due con le quali mi pagavo gli studi e anche altro. Avevo iniziato giovanissimo gestendo una fumetteria insieme a Vincenzo, compagno di università che aveva la passione per i fumetti e che, come me, aveva abbandonato l’Università. La sua non era stata una protesta però. Le condizioni economiche della sua famiglia erano mutate all’improvviso e non aveva potuto più permettersi di continuare gli studi. Il mondo del collezionismo, in generale, era per me incomprensibile. Quello dei fumetti in particolare lo era ancora di più, soprattutto all’inizio. Non comprendevo come ci si potesse appassionare alla lettura e soprattutto alla conservazione di tutta quella carta. Io nella mia vita avevo sempre rifiutato di conservare qualsiasi cosa, forse perché tutto quello che avrei potuto custodire mi avrebbe ricordato, a tempo debito, la mia famiglia e, con essa, il mio passato.
Tuttavia, col tempo, cominciai ad apprezzare quel mondo particolare, fatto di regole, informazioni e tanta, tantissima competenza, tanto che arrivai a frequentare numerose Fiere del settore o a rimanere da solo in negozio come unico referente.
Del resto quel lavoro girava attorno a un binomio semplice, ma estremamente variegato: compravamo e vendevamo fumetti. Non mi potevo lamentare di come andavano gli affari. Credo che all’inizio Vincenzo mi avesse chiesto di entrare in società con lui per una sorta di garanzia. Conosceva le condizioni economiche della mia famiglia ed essere in società con me lo faceva stare più tranquillo. Passavamo gran parte del nostro tempo anche a documentarci per evitare di sbagliare investimenti e rimetterci dei soldi.
Pian piano diventai esperto e, anche se non volevo ammetterlo con me stesso, mi stavo sempre più entusiasmando al mondo dei fumetti tanto da iniziare a collezionare, personalmente, alcuni pezzi di un certo valore, che conservo gelosamente nella libreria di casa accanto ai libri.
In verità, all’inizio del nostro rapporto professionale avevo accettato la proposta di Vincenzo di lavorare con lui perché mi piaceva Monica, sua sorella. Proprio così. Mi lasciai trascinare in questa impresa a causa sua. Pensavo che avrei potuto vederla spesso e avere qualche speranza di piacerle. Mi sbagliavo. Cercai di frequentarla in ogni modo, ma alla fine dovetti desistere quando mi resi conto che si era invaghita del suo professore di Fisica, sposato, più grande di lei di quasi vent’anni e con un’espressione stupida perennemente stampata sulla faccia.
Oltre al negozio, che mi occupava sei giorni su sette, dedicavo il tempo rimanente alla mia vera passione: la scrittura. Era nata quasi per caso e dopo la prima pubblicazione, del tutto insperata, si era evoluta a tal punto da diventare un lavoro. Mi piaceva scrivere. Mi riusciva con una certa facilità e mi consentiva di arrotondare i guadagni, all’inizio altalenanti, del negozio.
Scrivevo e pubblicavo di tutto: poesie, filastrocche per bambini, romanzi brevi e anche articoli sportivi per un paio di giornali di provincia.
Passavo tutto quello che scrivevo a Giulia, una mia ex compagna di università con cui ero rimasto in contatto. Il sodalizio con lei ebbe inizio una sera in cui, durante una festa in un locale, le avevo svelato la mia passione. Mi chiese cosa scrivevo e perché lo facessi.
Mi chiese anche se avessi mai pubblicato qualcosa. «Non ho mai pensato a ciò che scrivo come a un lavoro e per questo non ho mai sottoposto i miei scritti a case editrici» le risposi.
«Lo faresti?» mi chiese tra i rumori e le chiacchiere dei presenti.
«Sì. Credo di sì» le risposi.
A quei tempi lei aveva appena iniziato a fare l’editor per una casa editrice indipendente nata da pochi anni e mi disse che le avrebbe fatto piacere leggere qualcosa di mio. La ringraziai, le sorrisi e, bevendo l’ultimo sorso di qualcosa, di cui ignoravo il nome, le promisi che le avrei fatto avere il meglio del mio repertorio.
«Guarda che ci conto» mi disse salutandomi con un bacio sulla guancia.
Come le avevo promesso, nel giro di qualche giorno le feci avere due romanzi, una ventina di poesie e anche alcuni articoli sportivi che avevo scritto mesi prima immaginando di essere l’inviato di un’importante testata giornalistica sportiva. Puntuale e veloce, Giulia mi chiamò una sera e restammo al telefono per quasi un’ora.
«I tuoi romanzi mi hanno sorpreso» mi disse.
«Ti sono piaciuti davvero?» le domandai incredulo, pensando mi stesse prendendo in giro.
Non avevo mai pensato che potessero piacere a qualcuno oltre a me.
«Dico davvero. Vorrei farli leggere anche a un paio di miei colleghi. Qui siamo in parecchi, siamo giovani e ognuno di noi ha gusti diametralmente opposti. Se ti può consolare, ti vorrei dire che il tuo genere non è esattamente il tipo di lettura che mi entusiasma. Amo i noir, eppure sei riuscito a tenermi incollata alle pagine, dall’inizio alla fine» mi disse.
«Lo prendo come un complimento!» esclamai sorridendo.
«Lo è! Allora che faccio? Mi autorizzi?»
«Fai pure, sei autorizzata» le risposi.
Alcuni giorni dopo Giulia mi chiese di inviarle tutti i romanzi che avevo già pronti, le filastrocche e anche le poesie. Dopo due mesi venne pubblicato il mio primo romanzo e dopo tre mesi le mie filastrocche iniziarono a essere pubblicate su una rivista mensile dedicata alle neo mamme. In pratica, in ogni numero della rivista, era previsto un inserto centrale in cartoncino lucido e staccabile contenente una filastrocca, un disegno da colorare e una ricetta.
Se il lavoro nel negozio e la scrittura rappresentavano la fonte dei miei guadagni, l’attività fisica era il mio costo fisso. Un paio di sere la settimana, in orari quasi sempre impossibili, frequentavo la palestra di Stefano, un amico che conoscevo dalle elementari e bravissimo insegnante di ginnastica calistenica, una disciplina molto particolare che avevo scoperto da poco tempo, ma con radici antiche. Avevo capito, grazie alle sue spiegazioni, che potevo utilizzare il peso del mio corpo e la forza di gravità come resistenza passiva, per sviluppare la forza muscolare e migliorare il mio aspetto. Per quel tipo di ginnastica non servivano attrezzi. Tuttavia, c’era anche un altro motivo per cui mi sottoponevo ai duri allenamenti che Stefano mi preparava, un motivo che quasi non riuscivo a spiegarmi: sentivo che prima o poi il destino avrebbe chiesto al mio corpo di essere pronto, di mettere in pratica quanto stavo imparando.
Ero spinto da una motivazione che prima di allora non pensavo di avere. In pochi mesi i risultati furono sorprendenti e mi spinsero a proseguire e a intensificare gli allenamenti.
Mi sentivo in forma come non mi capitava da parecchio tempo.
La pancia era sparita e le tanto odiate maniglie dell’amore erano un ricordo lontano. Cominciavo a intravvedere i primi segni di qualcosa che era rimasto nascosto per troppo tempo: i miei addominali. Non avevo mai particolarmente amato lo specchio, ma da un po’ di tempo mi piaceva vedere la mia immagine riflessa. Anche le mie cosce e le mie braccia erano forti e toniche come non erano mai state. Più mi allenavo e più desideravo farlo.
Cercavo ogni volta di superare il limite della mia resistenza per essere sempre più potente, più scattante, più pronto. Era come se mi stessi preparando atleticamente per qualcosa che ancora ignoravo.
Ovviamente i miei genitori non vedevano di buon occhio entrambe le mie scelte, prima quella di gestire un negozio di fumetti, anche se insieme a un amico e poi quella di scrivere romanzi, poesie e filastrocche per bambini. Avevano immaginato un futuro professionale completamente diverso per me. Proprio per questo le mie scelte vennero vissute e interpretate da loro come un tradimento. Forse in parte lo fu. Forse, da parte mia, fu un modo per testimoniare il mio rifiuto a una vita preconfezionata da altri o solo la reazione di un figlio nei confronti di due genitori mai considerati all’altezza di un simile ruolo.
Mio padre mi avrebbe voluto in ufficio con lui, a prendere il suo posto quando sarebbe venuto il momento. Era un passaggio di testimone che non si sarebbe realizzato.
Dopo un’ora di autostrada e mezz’ora tra strade via via sempre più immerse nel verde della campagna, arrivai a casa dei miei nonni. La cerimonia funebre era stata fissata per le quattro del pomeriggio. Ero in perfetto anticipo.
C’erano molte vetture parcheggiate lungo il marciapiede e anche sull’aia davanti a casa dove normalmente parcheggiava l’auto mio padre. Mi sembrò di vederla, lucida e ferma sull’aia infuocata dalla canicola, ma sapevo che non poteva essere lì. Per un attimo chiusi gli occhi e ricordai l’ultima volta che l’avevo vista.
La casa dei miei nonni era disposta su due piani ed era circondata da un po’ di terreno che nonno Palmiro aveva adibito a orto e frutteto. La nonna aveva sfruttato come giardino solo una piccola parte di quel terreno. Negli anni ci aveva piantato una moltitudine di fiori. Li amava. Le piaceva vederli sbocciare. Nella parte posteriore vi era la stalla e sopra il fienile.
L’appartamento dove vivevano i nonni era anch’esso disposto sui due piani della casa: la camera da letto era al piano superiore, insieme con la stanza che era stata di mia madre e al bagno; al piano terra vi era la cucina e il soggiorno molto ampio e con un bellissimo camino in pietra. Tra la cucina e il soggiorno vi era un lungo corridoio che collegava l’appartamento alla stalla e che dava altresì accesso, attraverso una porta, alla cantina.
La sera in cui mio padre se ne andò osservai ogni cosa da lontano, con disinteresse, come se stessi guardando le ultime scene di un film che non mi era piaciuto e che finalmente si avviava ai titoli di coda, ma non era un film.
Ciò che i miei occhi stavano osservando era l’ultima sera in famiglia di un uomo, di mio padre. Avevo da poco compiuto trent’anni, ma in quei brevi e interminabili minuti mi sentii un bambino piccolo e solo. «Cosa ho sbagliato? Dove ho sbagliato?» pensai tra me, cercando di trovare, come figlio, la mia parte di responsabilità.
Era una serata buia e uggiosa di fine autunno e sembrava perfetta per un avvenimento come quello che mi apprestavo a vivere.
Adeguato al momento erano il suo cappotto scuro e il suo Borsalino, a cui tanto teneva, ben calato sulla testa, come a voler rendere quotidiano e normale un gesto che di normale e quotidiano non aveva nulla, almeno per me.
Immaginai che sotto il cappotto stesse indossando il suo abito preferito, perché da quella distanza potevo solo vedere dei pantaloni scuri, come quasi tutti quelli che aveva nell’armadio.
Pensai che non c’era un momento dedicato o ideale per andarsene di casa e quello che aveva scelto mio padre era in realtà un momento qualsiasi di un giorno qualsiasi. La sua pazienza era arrivata al capolinea e aveva deciso, una volta per tutte, di ribellarsi alla compagnia e al carattere di mia madre. Non sono mai stato capace di odiarlo per essersene andato. L’ho odiato per non avermi parlato, per non avermi spiegato le sue ragioni che, probabilmente, avrei compreso. L’ho odiato per avermi accomunato a mia madre, per avermi fatto sentire parte del suo problema con lei, parte del motivo per cui la sua pazienza era finita e aveva deciso di andarsene. Per quello, sì, l’ho odiato.
Oggi, dopo tutti questi anni, l’unico sentimento che prevale sugli altri, ripensando a mio padre, è quello che più si avvicina all’invidia. Anch’io avrei tanto voluto aggirare l’ostacolo e andarmene, chiudere quella porta alle mie spalle e tentare disperatamente di vivere la mia vita finalmente libero, ma rimasi appoggiato allo stipite della porta del soggiorno, come se qualcosa mi avesse incollato i vestiti a quel pezzo di legno.
Tenevo nervosamente le mani in tasca e mentalmente pregavo mia madre di intervenire, di fare qualcosa, qualsiasi cosa. «Mamma, fai qualcosa!» avrei voluto urlarle. Sperai fino all’ultimo istante nel disperato gesto di una moglie e madre che sta per essere lasciata.
Avrebbe dovuto giocarsi le ultime carte per convincere il marito a ripensarci, a tornare sulle proprie decisioni, a voler tentare ancora una volta di rimettere in piedi un matrimonio malandato. Avrebbe dovuto fare qualcosa che potesse far cambiare idea a un uomo stanco, a suo marito, a mio padre. Nulla. Non successe nulla.
Stupido! Mi sentivo uno stupido per aver pensato che mia madre potesse, anche solo per una volta, comportarsi come quelle donne che nei film americani del dopoguerra correvano disperate in vestaglia verso l’uomo che avevano amato per una vita intera pregandolo di fermarsi, di non oltrepassare quella soglia. Non successe nulla e lui, in silenzio e quasi al rallentatore, aprì la porta di casa, respirò profondamente e poi la richiuse alle sue spalle.
Gli potevo vedere le spalle, la nuca. Non avevo idea di cosa stesse pensando in quegli istanti o stesse facendo con la mano destra, mentre con la sinistra stava tenendo la valigia. Dal punto in cui mi trovavo il braccio destro era la sola parte del suo corpo che non riuscivo a vedere. Mi piacque immaginare che stesse tentennando, cercando nella parte più remota e nascosta della sua mente e del suo cuore una ragione per desistere, per tornare indietro dai suoi propositi, per rimanere con me. Forse anche lui stava aspettando un ultimo gesto da parte di mia madre. Non fu così. Nulla avvenne. Non ci fu alcun gesto. La porta si aprì e lentamente si richiuse alle sue spalle.
Non so cosa si fossero detti, nel silenzio della loro camera da letto, prima di quella scena finale. Francamente non so nemmeno se si fossero detti qualcosa, un addio, una spiegazione o altro.
A me, sicuramente, il dottore non disse nulla. «Maledetto figlio di puttana!» urlai in silenzio dentro di me. «Ero tuo figlio e meritavo almeno una spiegazione.»
Mi sarei aspettato almeno un addio! Rimasi fermo a quello stipite anche per i minuti successivi. Avrei voluto sparire, morire. Anzi no. Avrei voluto non essere mai nato. A un tratto mi ricordai di respirare. Fu come essere afferrato per i capelli da qualcuno che mi aveva visto galleggiare a pelo d’acqua. Tornai a respirare e mi accorsi che mi sentivo solo, esattamente come il giorno, il mese e gli anni precedenti.
Quell’uomo non mi aveva lasciato nulla. Non ricordavo una sola serata trascorsa in sua compagnia. Non ricordavo una passeggiata o una domenica pomeriggio passata a giocare con mio padre. Non ricordavo qualcosa che valesse la pena di essere ricordato. Attribuii la responsabilità di quella improvvisa amnesia al mio disperato bisogno di ricordare eventi di quando ero bambino. In realtà non ricordavo nulla di simile nemmeno dei tempi più recenti.
Mi resi conto di non avere ricordi.
Sorrisi amaramente e dopo aver respirato mi resi conto all’improvviso che l’aria di casa mia non aveva odore. Com’è possibile? In tutti i romanzi che avevo letto c’era sempre una parte in cui si descrive l’odore di casa come qualcosa di unico, di familiare, che rimane dentro il cuore e la memoria per sempre come un meraviglioso e unico marchio indelebile. In casa mia no. Avevo respirato più forte l’aria che avevo attorno, ma non vi erano odori che avrei potuto memorizzare e riconoscere.
Mi incamminai lentamente verso la mia camera, tolsi le mani dalle tasche e passai davanti alla camera di mia madre. La luce era accesa e la porta era socchiusa e così sbirciai dentro.
Lei era seduta sul bordo del letto, nella sua vestaglia nera, le mani appoggiate sulle cosce e la testa ferma e diritta davanti a sé.
Stava fissando qualcosa, forse lo specchio o un altro punto che non potevo vedere da lì. Probabilmente aveva sentito i miei passi avvicinarsi e poi fermarsi davanti alla porta della sua camera, ma non si voltò. Avrei voluto che per un attimo, solo per un attimo, mi chiamasse, mi tenesse stretto a sé come non aveva mai fatto in vita sua. Avrei voluto parlarle, rassicurarla, farle sapere che non doveva preoccuparsi di nulla perché io sarei rimasto accanto a lei, perché lei era mia madre.
Avrei voluto solo un gesto da parte sua e invece rimase immobile e fredda come una statua di marmo. La osservai per un po’ e poi proseguii. Richiusi la porta della mia camera alle mie spalle come il dottore aveva chiuso la porta di casa qualche minuto prima. Mi sembrava che fosse trascorso un secolo dalla sua uscita di scena. Mentre lui andava incontro alla ritrovata libertà, io mi buttai sul letto e, senza piangere, pensai ai nonni. Mi aggrappai all’unica cosa bella che mi era rimasta.
A quel punto riaprii gli occhi e tornai al presente. Davanti alla casa dei nonni non c’era spazio, e per questo decisi di proseguire e parcheggiare più lontano. Prima di scendere dall’auto mi guardai attorno. Ben poco era rimasto uguale in quel luogo. O forse, quello cambiato ero io. Non c’era più l’orto e le piante da frutta sembravano di meno e anche più piccole. Presi la giacca blu dal sedile posteriore e mi infilai gli occhiali da sole.
Avevo smesso di dare peso alle speranze e ai desideri dei miei genitori quando avevo lasciato l’università. Entrambi avevano sperato che dopo gli studi volessi prendere il posto di mio padre. Speranza che rimase vana, sia per la laurea che per le scelte professionali che feci in seguito. Avrebbero altresì voluto vedermi sposato e accanto a una donna. Ormai, a quarant’anni da compiere, era passato il tempo del matrimonio, almeno per me.
Subito dopo aver abbandonato gli studi, a pochi esami dalla laurea, per mia madre non sarebbe stato ammissibile che rinunciassi anche all’idea di prendere moglie. Nel periodo che intercorse tra i miei venticinque e trent’anni mi chiese ripetutamente della mia vita sentimentale e in alcune occasioni si spinse persino a organizzarmi incontri con le figlie delle sue amiche. Mi sentivo come lo scapolo da piazzare: a tutti i costi, voleva vedermi sposato. Francamente non ho mai capito questa sua frenesia, dal momento che non mi era mai sembrata una persona da prendere ad esempio, per quanto riguardava la vita a due, con o senza matrimonio.
Forse era il suo modo di voler sempre e comunque rispettare dei cliché. In questo caso lei stava rispettando il ruolo di mamma e io avrei dovuto rispettare il ruolo di figlio in età di fidanzamento.
Fino ai diciassette anni non mi persi una vacanza a casa dei miei nonni. Purtroppo da loro le giornate trascorrevano sempre troppo velocemente, forse perché le cose da fare erano tante e forse perché ci stavo davvero bene. Man mano che crescevo si radicava in me la convinzione che mia madre fosse diametralmente diversa dalla nonna e da quel ragazzo morto in guerra che avevo imparato a conoscere e amare attraverso le poche fotografie in bianco e nero e i racconti di mia nonna. Mia madre non aveva preso nulla nemmeno dalla vicinanza di nonno Palmiro.
Al funerale avrei voluto non vedere nessuno, non salutare nessuno, ma sapevo che non sarebbe stato possibile. Respirai profondamente e poi mi incamminai. Ora ero lì, per l’ultimo saluto alla sola donna che fino a quel momento avesse avuto davvero un significato nella mia vita. Alzai lo sguardo al cielo. Ancora non potevo immaginare che un uragano si stava per abbattere su di me.
Dopo due giorni di coma, il cuore di nonna Claretta si era arreso. Avrebbe dovuto compiere novantun anni tra pochi giorni. Nonno Palmiro, invece, ci aveva lasciato qualche anno prima.